Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
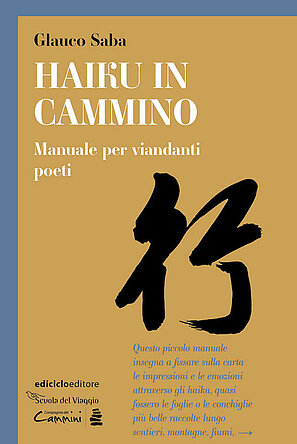
Glauco Saba, Haiku in cammino, Manuale per viandanti poeti, Ediciclo editore, Portogruaro, 2023.
Haiku e l’illuminazione del quotidiano
Il poeta Glauco Saba ci racconta l’origine giapponese dei tre versi che intrecciano le parole all’«esperienza del cammino»
Alessandro Cristallo
«Tra le caratteristiche umane più ancestrali vi sono la camminata bipede e l’espressione vocale ritmata o cantata» è questo l’incipit del libro Haiku in cammino, Manuale per viandanti poeti, con il quale l’autore Glauco Saba, pseudonimo di un docente della Scuola del viaggio di Milano, fornisce ai lettori «uno strumento agile nella forma e nelle dimensioni per chi voglia gradualmente affiancare la scrittura di haiku alle proprie esperienze di viaggio».
L’Haiku è una forma di poesia breve di origine giapponese con una metrica precisa e temi prestabiliti. Tradizionalmente è scritta in kanji, ovvero con i caratteri orientali che a loro volta – per una questione grafica e comprensibile ovviamente più a chi conosce questa meravigliosa arte dello scrivere con logogrammi – possono formare una sorta di guida spirituale dei viaggiatori, per raggiungere nuovi orizzonti e trovare nuovi equilibri.
Al di là della metrica, i temi sono tre: il primo dovrebbe tradizionalmente essere di tipo naturalistico ovvero dare spazio alla figura di un animale, un fiore, una pianta o un fenomeno meteorologico; solitamente questo concetto viene espresso all’interno della prima frase.
La seconda frase divide concettualmente e foneticamente lo Haiku in due parti, con lo scopo di poter far immaginare al lettore un universo di scenari appartenenti al «non detto». La frase conclusiva (dato che sono solo tre) si riferisce alla ciclicità del tempo.
Grazie a poche parole, la scrittura Haiku proietta il lettore nel proprio mondo permettendogli di intraprendere un cammino.
Il padre degli haiku è Bashō, in origine Matuso Munefusa (1644-1694). Ideò questa forma di scrittura assumendone la pratica, al pari di un «cammino attraverso la natura come nella vita». La prospettiva con cui egli vedeva il mondo, e la sua apertura verso il reale, è ben riassunta dall’autore del manuale: «Camminare ci permette di cogliere quei minimi mutamenti del mondo reale che altrimenti ci sarebbero sfuggiti, a patto però di essere aperti e ricettivi verso ciò che accade al nostro esterno».
Chi pratica questa poesia non si esprime normalmente in prima persona, ma lo fa attraverso le sue sensazioni ed emozioni, scegliendo elementi oggettivi del mondo esterno di facile condivisione con il lettore.
Per Bashō, l’interesse cardine in qualità di viandante moderno, secondo quanto è riportato da Saba, era quello di «cogliere la realtà attraverso i dettagli e renderla in forma adeguata sotto forma di Haiku», ed è proprio questa la formula per aspirare ancora oggi ad essere un vero viaggiatore. Quando noi camminiamo, ci immergiamo in una realtà costituita da luci, forme, colori, profumi e suoni, i quali ampliano sia il nostro orizzonte, sia il nostro bagaglio emotivo.
Il viaggio, il cammino anche in senso metaforico, emerge in quasi tutti gli haiku, anche nella sua accezione negativa, l’anti-viaggio: «Questo sentiero / nessuno lo percorre / sera d’autunno».
Nel «manuale per viandanti poeti si trovano dunque delle riflessioni sulle caratteristiche della poesia haiku e sui suoi legami con l’esperienza del cammino, illustrate da una scelta personale di haiku significativi. La parte antologica non è però arbitraria, ma è formata soprattutto a partire dall’opera degli antichi maestri del genere» com’è stato per l’appunto Bashō, il quale da ex samurai si è poi dedicato allo Haiku per tutta la sua vita restante: «L’identificazione di Bashō con l’esperienza del viaggio è cosciente e totale fino alle estreme conseguenze: morirà nell’autunno 1694 proprio sul cammino verso Osaka, accomiatandosi dai discepoli e dal mondo con questo haiku: «malato in viaggio / sui campi bianchi ancora / vagano i sogni».
Glauco Saba, nel suo manuale per viandanti poeti, tuttavia, non resta solo nella scia del maestro, bensì rende conto anche dell’evolversi di questa letteratura: «La poesia haiku si è evoluta in modi differenti sia in Giappone che all’estero; tuttavia in molti “compagni di cammino” è tuttora presente una consonanza con i temi e i modi classici che confermano la validità di questa forma poetica nell’esprimere tutte le stagioni dello spirito».
Ne è uno splendido esempio Maria Laura Valente, haijin italiana di risonanza internazionale, con i suoi haiku la cui delicatezza e profondità di sentimento imprimono una cifra inconfondibile: «Di nuovo in viaggio / i rami dei salici / sciolti nel vento // lungo cammino / di ogni foglia caduta / serbo ricordo // pellegrinaggio / mi accompagna in silenzio / la mia ombra» (M.L. Valente, La carezza del vento (2018).







