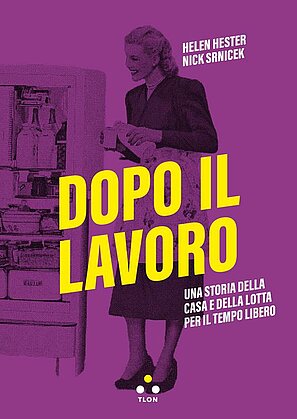Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Siamo schiavi degli elettrodomestici?
In un nuovo libro due ricercatori inglesi raccontano quanto tempo perdiamo a riordinare le nostre case, quando invece potremmo pensare a nuove forme di condivisione collettiva
Stefania Prandi
Le nostre case sono piene di elettrodomestici – lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere, macchina per il caffè, frullatore – pronti ad aiutarci in qualsiasi momento. Eppure, come spiegava già quarant’anni fa la storica americana Ruth Schwartz Cowan, nonostante tutta questa tecnologia al nostro servizio, il tempo che dedichiamo alle faccende domestiche non è diminuito rispetto al passato (quando le nostre bisnonne lavavano i panni nelle tinozze o al fiume).
Helen Hester, docente di Genere, tecnologia e politiche culturali alla University of West London e Nick Srnicek, politologo e docente di Economia digitale al King’s College di Londra, hanno deciso di dedicare un saggio partendo da quello che si può definire «il paradosso di Cowan»: avere automatizzato molti lavori domestici, restando comunque invischiati nelle pile di panni da lavare, piegare e stirare e nelle cucine da rassettare.
Con il libro Dopo il lavoro. Una storia della casa e della lotta per il tempo libero (Tlon) ci avvertono che è arrivato il momento di invertire la rotta. Più facile a dirsi che a farsi, viene da pensare, mentre ascoltiamo il rumore dell’ultima lavatrice che abbiamo caricato. Eppure possiamo fidarci delle loro intuizioni perché Hester e Srnicek sanno bene di cosa scrivono: entrambi genitori di tre figli piccoli, hanno lavori a tempo pieno e sono una coppia anche nella vita.
Le cause del tempo eccessivo che dedichiamo alla pulizia e alla cura dei figli sono dovute a diverse ragioni, spiega Helen Hester ad «Azione»: la prima tra tutte è l’aspettativa sociale. La concezione di cosa sia pulito o sporco è costruita socialmente e i miglioramenti ottenuti con gli elettrodomestici hanno portato a un’escalation dei nostri standard: se l’aspirapolvere è più potente, ci aspettiamo tappeti più immacolati. «Prendiamo il bucato, per esempio – dice Hester. – Con l’introduzione della lavatrice domestica, si è cominciato a faticare meno ad avere vestiti puliti, ma le persone hanno iniziato a fare più lavaggi. Negli anni Sessanta, la maggior parte delle famiglie lavava i panni un paio di volte a settimana». Adesso, c’è chi fa anche due lavatrici al giorno, soprattutto se ha dei figli. C’è l’idea che se possiamo fare di più, allora dovremmo spingerci oltre. I dispositivi domestici sono diventati dei «sorveglianti» silenziosi – come delle spade di Damocle sulle nostre teste – che rappresentano tutto il lavoro che potremmo e dovremmo svolgere.
Ma sarebbe ingiusto dare la colpa soltanto alla tecnologia. Siamo influenzati anche dall’industria pubblicitaria che modella i nostri bisogni e ne inventa sempre di nuovi. Pensiamo, ad esempio, ai robot lavapavimenti – chi non ne ha desiderato uno, almeno una volta nella vita? E quando smettiamo di pensare all’ordine delle nostre case tirate a lustro, attacchiamo con l’ossessione per la cura dei bambini e dei teenager: «La crescente ansia per il futuro del mercato del lavoro ha incoraggiato una genitorialità più intensiva: dedichiamo molto tempo alle attività educative e a trasportare i figli alle diverse attività extracurriculari». Certo, restano delle differenze tra i diversi Paesi. «Se gli inglesi, ad esempio, trascorrono meno tempo a cucinare, rivolgendosi sempre più al take-away e alle cene surgelate, lo stesso non vale per i francesi, che continuano a difendere la loro reputazione nazionale su questo fronte».
Forse ci troveremmo in una situazione diversa se la Storia avesse preso una piega diversa. Saremmo più liberi, magari, se avessero preso il sopravvento le pratiche dei riformatori sociali del Diciannovesimo secolo che sostenevano la socializzazione del lavoro domestico, con lavanderie e cucine di alta qualità operanti su scala di quartiere. Nel libro Dopo il lavoro c’è una sezione sulle cucine comuni e le strutture per l’infanzia della Russia rivoluzionaria, che negli anni Venti fecero parte di un tentativo sostenuto dallo Stato di liberare le donne dal lavoro domestico e di sostituire la famiglia tradizionale. L’esperimento fallì dopo alcuni anni, minato dalla mancanza di risorse, da una svolta verso il conservatorismo sociale sotto Stalin e dalla difficoltà di cambiare abitudini radicate. Ma la logica della condivisione di elettrodomestici costosi e dei lavori domestici laboriosi attraverso una vita comunitaria ha attirato anche società meno radicali, come gli Stati Uniti, la Finlandia e l’Austria.
A Vienna, ad esempio, un governo cittadino pionieristico di centrosinistra ha costruito complessi residenziali pubblici innovativi e tuttora ammirati, con strutture che vanno dai laboratori alle lavanderie, ritenendo che gli inquilini dovessero godere di «sufficienza privata» e di «lusso pubblico». Secondo Hester e suo marito, questi esperimenti «offrono ancora risorse allettanti» per ripensare la vita domestica dei giorni nostri. A Londra, dove vivono, esistono esperimenti interessanti che potrebbero funzionare da modello su larga scala. Si potrebbero, ad esempio, istituire servizi di noleggio locale di vestiti per bambini e condividere la spesa di «tecnici» tra gruppi di famiglie per affrontare i problemi informatici quotidiani.
Tuttavia, anche cambiamenti modesti richiedono un cambio di mentalità non da poco. Bisognerebbe passare dalla visione individualistica, nella quale siamo immersi fino al collo, a un approccio comunitario. Dovremmo immaginare di trascorrere più tempo fuori casa, insieme agli altri, in compagnia, in luoghi gratuiti e di qualità: centri ricreativi, piscine, biblioteche, spazi artistici, parchi pubblici e campi da gioco. Questa trasformazione dovrebbe poi combaciare con un’altra grande svolta della quale si parla molto, ma per la quale si fa ancora poco: ridurre il tempo di lavoro per guadagnare lo stipendio. «Sacrifichiamo il tempo libero, dimenticando che il tempo è la sostanza stessa della nostra vita. Dovremmo avere settimane lavorative più brevi, riconsiderando al contempo tutto il lavoro che svolgiamo a casa». Secondo Hester, «gli sforzi individuali possono portarci solo fino a un certo punto, perché inevitabilmente ci scontriamo con forze sociali implacabili. Speriamo che il nostro libro possa spingere a riflettere e a riorganizzarsi. Nel frattempo – conclude – non fa male anche smettere di stirare».