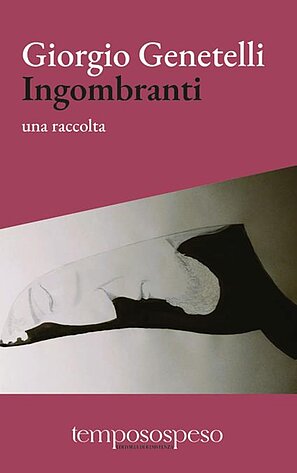Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Tra Preonzo e McCarthy
Racconti: nella nuova raccolta di Genetelli si ricompone un mosaico narrativo di rifiuti e affetti, oggetti perduti ed emozioni ritrovate
Stefano Vassere
La parola ingombrante è, linguisticamente, un risparmio: deprivata com’è del sostantivo rifiuto, finisce per organizzarsi in proprio, assumendo una formula virtuosamente sospesa di connotazioni di efficienza, che è tipica per esempio di certa parsimonia elvetica: ritiro ingombranti, ingombranti non riciclabili, regolamento ingombranti. Di più, liberato della qualifica di rifiuto, l’ingombrante è passione relativa: sono mobiletti, divani, materassi, gabinetti, ma anche vecchi PC, televisori, giochi elettronici e altri scarti, che venuti a noia per taluni finiscono per fare la gioia di altri. Le memorabili notti del loro ritiro a domicilio si popolavano in passato di efficienti camioncini che caricavano di tutto in giro per le città e gli attuali centri di raccolta riservano angoli di libero servizio, perché non si sa mai che questo o quell’utensile, quel tappeto, i libri rimasti dell’ultimo trasloco, possano trovare, bontà loro, una nuova casa.
Ingombranti (Minceto GE, Temposospeso, 2025) è il titolo dell’ultima produzione dello scrittore e giornalista Giorgio Genetelli, che porta, perfezionando la metafora, Una raccolta come sottotitolo. Diremo subito e per toglierci il pensiero che questo libro è opera ottima, anche nel tenere insieme nella stessa casa registri e contenuti molto variabili. Si è spesso disattenti all’architettura interna delle raccolte di prose, ma si badi qui per esempio a questa specie di cornice biblica: nel primo racconto a parlare è un nascituro che ha il papà che lavora in Samaria e una mamma che è incinta non conoscendo il sesso, che prevede che «tre tizi» verranno con regali beneauguranti eccetera; nel penultimo ritroviamo due malandrini (due ladroni) che si chiamano Tito e Dimaco e che attendono di essere giustiziati, con un terzo che assiste e che dice cose a proposito di una certa Maddalena, sua amata. In mezzo, come detto, gli stili e le vicende si differenziano: insieme a un universo genericamente locale, c’è qualche d’après da autori famosi, esempi di prosa calcistica paesana, narrazioni di struggenti episodi-memorabilia.
Nell’ordine, tra le cronache del mondo più prossimo brillano le vicende scolastiche del paese, con i compagni dai nomi italiani esotici che entrano nella comunità o ne escono; il culto della pagina dei morti nei quotidiani (forse ultimo ma irriducibile baluardo in tempi di crisi dei cartacei); aneddotiche riguardanti le tragiche e reiette figure marginali del villaggio; i costumi posticci scavallati ormai nella modernità, che si sostanziano nei vani tentativi di produrre una birra casalinga. Tra gli omaggi, uno è esplicito: leggendo le prime righe di Questo vento e al cospetto di due anime disperate, padre e figlio, che vagano sole per un grigio inferno post apocalittico, non bisognerà arrivare fino in fondo per scoprire un ciao a La Strada di Cormac McCarthy; e tutt’al più si apprezzerà la piccola frizione dovuta alla libertà di far parlare il padre in italiano e il figlio in dialetto della Riviera. Ma è già allineato con il genere il testo precedente, Vago per la città, di ambientazione tra Truman Show e Squid Game, che prelude all’emigrazione catastrofale dei due, tra supermercati cadenti e cupe scarpinate di notte.
Hanno il sentore fibroso di quella lingua cormachiana anche altri passi isolati; sentite questa: «il fumo di mille sigarette, incatramato dai decenni, balza fuori, mi travolge facendomi cadere e fugge via nella notte, inseguito dall’afrore di vino e sudore e da uno sciame di bestemmie incolte». Non è finita, con gli omaggi e i modelli: non avrebbe stonato nota omologa a quella della Strada per l’allineamento in stile Edgar Allan Poe del racconto Quella notte di dicembre, il cui finale, dopo passi concitati nell’oscurità dei vicoli, incontri con gatti, ombre che si ricompongono, suona così: «con orrore guardai il lungo coltello scarlatto. Quando alzai gli occhi vidi l’esile figura uscire dalla sala e sparire per le scale. Il vento aveva ripreso il suo sibilo gelato».
La varietà – già e già detto – è uno dei valori di questa raccolta; in rassegna impressionistica meritano menzione anche il viaggio in Italia con furgone VW tipo figli dei fiori e amica con nastro tra i capelli, le cronache di disperati e polverosi derby calcistici Preonzo contro Gnosca, qualche struggente omaggio ai genitori, il racconto di canone «libro nel libro» che si intitola Alle tre del pomeriggio. Gli stili, allineati con questa varietà, sono l’altro grande pregio di un libro che non si ha tema di mettere tra i migliori che la narrativa locale abbia prodotto negli ultimi anni e che porta peraltro un bel vestito editoriale e dichiarazioni di responsabilità degli editori.
Endlich, non è un caso che la nuova raccolta di Giorgio Genetelli si intitoli proprio come si intitola. Uno stile improntato a quell’economia circolare del rifiuto, che ha dalle nostre parti vari imprinting, uno dei quali è autenticamente contadino, milieu che occupa le parti più qualificanti di questo libro. Il codice di quei tempi andati è stato un timbro culturale storicamente limitato nell’espressione di affetti e sentimenti, per i quali nemmeno aveva un proprio lessico, ma poi ha avuto indiscussa abilità nel maneggiare allusioni, occhiolini, sottintesi. Rispetto ad alcuni cantori di quella civiltà, i testi locali di questo libro hanno però un pregio nuovo: quello di rinunciare a un diffuso tono dolente e lamentoso, incline a sottolineare sciagure e destini ingrati, e di scegliere la pratica di quel po’ di gaie facezie che pure devono avere abitato quel mondo di antiche contrade.