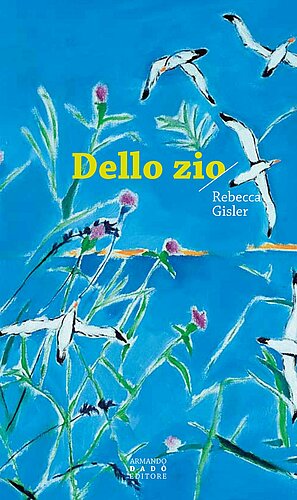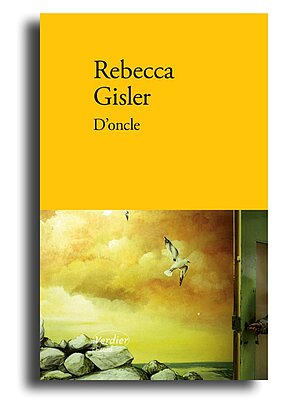Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Cronaca di una convivenza stravagante
Letteratura: la tensione tra normalità e devianza in un paesino bretone attraverso lo sguardo di una nipote testimone dell’umanità complessa dello zio
Roberto Falconi
Si dice spesso, e con molte ragioni, che la miglior letteratura sia quella che prende atto dell’opacità del mondo e della difficoltà di accedervi pienamente, facendo di questo scacco conoscitivo l’oggetto stesso della propria trattazione. Nel suo romanzo d’esordio – uscito nel 2021 presso Verdier, e ora disponibile anche nella traduzione italiana approntata da Luigi Colombo – Rebecca Gisler indaga il rapporto tra normalità e devianza e, in conclusione, il velleitarismo di ogni tentativo di omologare la marginalità.
Il libro si fa anzitutto campo di tensione tra uno zio disadattato e la nipote (e narratrice), che per motivi mai del tutto chiariti si ritrovano a condividere la casa di lui in Bretagna, in un paesino affacciato sulla baia e sulla fine del mondo. Ora, già la scelta della figura dello zio, letterariamente minoritaria, permette uno sguardo obliquo e problematico sulle cose; salvo che questa lateralità si fa ossessiva centralità: l’edizione originale presenta in un centinaio di pagine 484 occorrenze della parola oncle, tutte conservate nella traduzione. Uno zio cinquantenne mai davvero uscito dall’infanzia, verduraio presso l’abbazia dopo esserne stato giardiniere paesaggista, che divide il proprio tempo libero tra la caccia alle talpe in giardino e il tiro con l’arco («ci chiede di portarlo al negozio di sport, dove si compra delle medaglie che non manca di attribuirsi solennemente al termine di una seduta di tiro particolarmente riuscita»). Per il resto, lo zio guarda spesso la televisione (anche quando non funziona più: lo sguardo resta fisso sul rettangolo nero macchiato dalle sue impronte digitali), cura – diciamo così – la propria alimentazione («che è composta in gran parte da sandwich con l’andouille inghiottiti nel segreto della sua camera») e la propria igiene («quando lavorava, lo zio si lavava una volta alla settimana, e al minimo cambiamento di programma, in vacanza per esempio, lo zio non si lavava più del tutto»).
Lo spazio del libro è interamente occupato dall’osservazione, da parte della nipote, del fenomeno-zio: nessuna riflessione psicologica, nessun giudizio morale; solo uno sguardo vigile, a tratti ironico, a tratti preoccupato, sempre empatico. Ne esce un resoconto che si muove tra iperrealismo (le condizioni in cui lo zio lascia il cesso) e toni onirici (la galleria di animali esotici che escono dall’ospedale in cui viene ricoverato a seguito di anni di vita sregolata), a volte tra loro indistinguibili, come «la linea dell’orizzonte si confonde con la linea del mare e forma un’unica parete grigia». Proprio la natura risulta respingente, incisa dalle tensioni che animano il romanzo: l’edera che soffoca la casa dello zio; il mare che quando si ritira lascia dietro di sé una baia inaccessibile, putrescente, tutta spigoli («due o tre piccoli scogli, alghe verdi che sanno di zolfo, e dei carapaci di granchio o delle conchiglie di cozza»). Nessun idillio nemmeno a primavera, quando lo zio, senza neppure lasciare il letto, «sfodera la sua racchetta elettrificata per massacrare le mosche, che si nutrono del sangue dei mammiferi che parassitano». Anche il giardino della casa si fa allora spazio antiedenico, superficie che riflette il conflitto tra devianza e normalizzazione, con il fratello della narratrice (che per un periodo condivide con lei il soggiorno bretone) che sfascia il frutteto a cui si è premurosamente dedicato nell’indifferenza dello zio, del tutto insensibile alla bellezza e interessato solo all’azione: «un duello di gabbiani o un transito di ricci».
L’opacità delle cose investe anche il piano della Storia. Alla precisione calendariale (lo zio lascia con i genitori la banlieue parigina «nel luglio millenovecento novantadue», all’età di venticinque anni; nel corso del romanzo ne compie cinquantatré) si oppone la parziale reticenza nell’indicare esplicitamente i motivi – peraltro chiarissimi – di una convivenza forzata («diceva che il virus si propagava tramite le punture di mosche», «alla televisione avevano detto che le frontiere degli stati stavano per chiudere»). E alla devianza della Francia, centrifuga e periferica, fatta di bettole e personaggi marginali, si oppone l’immagine velleitariamente patinata della Svizzera (dove la narratrice vive con la madre), in cui le vacche sorridenti mostrate nei documentari si scontrano con una realtà fatta di conigli morti e di gatti malati alla tiroide.
Salute e patologia si confondono in un cortocircuito per cui i personaggi che circondano uno zio zoppo e obeso (ma sereno: «tutto, a suo modo di vedere, è questione di abitudine») – pretendendo magari di occuparsene – sono in realtà più malati di lui: i suoi nipoti, che si scuoiano a furia di grattarsi per un disturbo psicosomatico; sua sorella, divorata dalle paranoie; i vicini di casa, ormai sprofondati nel delirio.
Il romanzo – a tratti letterariamente mediato (i riferimenti espliciti a Franz Kafka e a Emmanuel Bove) – si interroga quindi sulla propria difficoltà di accedere alla complessità del mondo, come emblematicamente mostrano la triplice occorrenza (sempre parte di una similitudine) del «menhir nella nebbia» e i tre colleghi di lavoro dello zio, tutti di nome Erwan e quindi indistinguibili l’uno dall’altro. E come peraltro già annuncia l’esergo di Eugène Savitzkaya: «Sono una corteccia piena di carne ineffabile o una carne ineffabile avvolta nella corteccia?».
Credo che possa essere letta in questa prospettiva anche la tensione che si instaura tra la sintassi magmatica e ossessivamente ripetitiva di cui sono costituiti i lunghissimi paragrafi e la sostanziale esilità dei legami tra i vari blocchi testuali. E sarebbe allora necessario – restringendo al testo in italiano – un supplemento di indagine sull’uso del congiuntivo, che mi pare uno degli aspetti più problematici della traduzione di Luigi Colombo.
A costituire l’impianto metanarrativo del romanzo concorrono elementi che emergono in modo più o meno patente sulla tavola testuale: il fratello della narratrice che non crede si possa scrivere un romanzo su «uno zio che neanche è morto»; i due nipoti che condividono – oltre a una lingua segreta invidiata dalla madre – la medesima professione di traduttori di istruzioni di alimenti per animali. Indicatori di una preoccupazione espressiva che coinvolge la stessa Rebecca Gisler, di lingua madre francese ma che sinora ha sempre scritto solo in tedesco, tanto che il romanzo (linguisticamente trasgressivo e sperimentale sin dal titolo: D’oncle) potrebbe essere letto come una sorta di apprendistato dell’autrice nel trovare le parole che meglio aderiscono alle cose.
L’unica pacificazione possibile per le tensioni che attraversano il testo sembra essere l’accettazione delle spinte centrifughe, come nell’ultima pagina mostra la nipote accovacciandosi accanto allo zio per strisciare insieme a lui sotto la siepe alla ricerca di uova di fagiano. Assecondare la devianza può forse aprire a quel sorriso – pur se sghembo e sgraziato – sul quale il libro si chiude.