Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Bibliografia
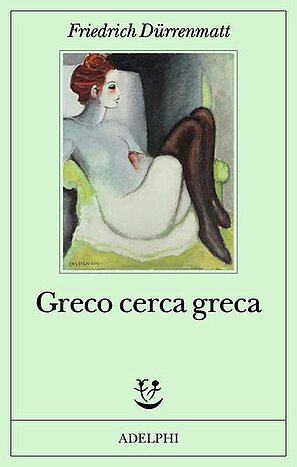
Friedrich Dürrenmatt, traduzione di Margherita Belardetti, Greco cerca greca, Adelphi, 2024.
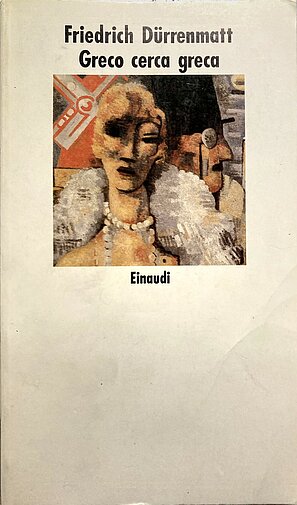
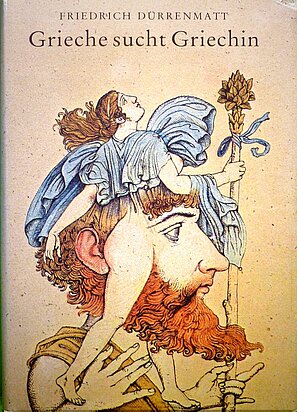
Dürrenmatt oggi: come rileggere un classico?
Letteratura comparativa: con la nuova edizione di "Greco cerca greca" si ripropone la riflessione sulla fedeltà traduttiva e sul potere delle diverse scelte stilistiche
Manuela Mazzi
Geniale, ironico, pungente, Friedrich Dürrenmatt ha affascinato da sempre i suoi lettori con trame caustiche e allegorie filosofiche. Così ha fatto anche in Greco cerca greca (Grieche sucht Griechin. Eine Prosakomödie, Verlag der Arche, 1955): non uno dei romanzi più noti, ma per noi forse il più riuscito. Quella che potrebbe venir definita una favola moderna incarna infatti tutto lo stile corrosivo e tagliente dell’autore svizzero, maestro nel mettere a nudo i paradossi della società borghese soprattutto di Zurigo, quale città assurta nei suoi lavori a emblema elvetico.
In Greco cerca greca Dürrenmatt ha creato una farsa caricaturale che delinea in modo divertente e crudele il mondo afflitto dal perbenismo, dai giochi di potere, dai valori distorti, dalla banalità dei bluff dell’essere umano, dal dilagante servilismo ipocrita, dalla pochezza dei sentimenti nobili, dai falsi miti, dal potere del sesso che fa girare l’universo,… dando spazio a quel suo sarcasmo sottile, che non si è mai limitato a deridere i conformismi del suo tempo, ma ha esplorato la fragilità dei sistemi morali che regolano il mondo moderno. E oggi, dopo anni in cui era fuori catalogo e dunque pressoché irreperibile, questa «commedia in prosa» è tornata sugli scaffali grazie a una nuova traduzione di Margherita Belardetti, pubblicata da Adelphi (2024), che ha di certo il merito di aver ridato vita a quest’opera.
Nel solco della… traduzione
Ma come si inserisce questa nuova versione nel solco tracciato dalla storica traduzione di Mario Spagnol, datata 1963 per l’edizione Feltrinelli, e ripresa nel 1975 per le edizione Einaudi?
La traduzione di un’opera come questa rappresenta sempre una sfida. Dürrenmatt ha costruito un linguaggio che, nella sua apparente semplicità, nasconde intricati giochi di significato e ironia, spesso – e diremmo quasi giocoforza – legati al contesto culturale svizzero. La scelta delle parole non è mai neutra, e ogni traduzione, per quanto fedele, inevitabilmente riflette la sensibilità del traduttore, non solo la lingua d’arrivo. Nel caso di Belardetti, traduttrice di buona esperienza (che ha già saputo confrontarsi con autori di grande calibro come Robert Walser e lo stesso Friedrich Dürrenmatt, Il sospetto nel 2022), questo processo a noi sembra che si sia qui manifestato attraverso una maggiore morbida fluidità del testo, che potrebbe avvicinare il lettore italiano a Dürrenmatt, ma non senza qualche inevitabile perdita lungo il percorso; perdita che ci permette di dare spazio a riflessioni sul grado di fedeltà letteraria mantenuto, o no, rispetto all’originale e all’edizione precedente.
Un paragrafo da esempio
Nel farlo, ci avvaliamo di un paragrafo che riportiamo nelle due versioni italiane per permettere al lettore di seguire le nostre considerazioni:
Traduzione di Mario Spagnol, 1963 – «Loro stavano sul quai, davanti al palazzo del Presidente. Il fiume era gonfio e fangoso; lo attraversavano ponti dalle ringhiere arrugginite; passavano chiatte vuote con i pannolini stesi ad asciugare e i capitani infreddoliti che, la pipa in bocca, andavano su e giù per la coperta. Le strade s’erano riempite d’una folla domenicale: nonni solenni accompagnati da lindi nipoti, famiglie in riga sui marciapiedi».
Traduzione di Margherita Belardetti, 2024 – «Si trovavano sul lungofiume, davanti al palazzo presidenziale. Il fiume era color del fango, rigonfio oltre-misura. Ponti dai parapetti arrugginiti lo scavalcavano, chiatte vuote passavano con panni stesi e capitani infreddoliti che andavano avanti e indietro sulla tolda, fumando la pipa. Ovunque un brulichio domenicale di folla a spasso: nonni parati a festa con nipotini in ghingheri, famiglie accalcate sui marciapiedi».
Diciamo subito che abbiamo altresì effettuato un confronto con l’originale grazie all’aiuto di una traduttrice svizzera di nostra conoscenza, trovando che ci sia maggior fedeltà letterale (i panni sono in verità pannolini, anche in tedesco; ah! La satira può nascondersi persino nei diminutivi) oltre che culturale, secondo noi, con la versione di Mario Spagnol, nonostante tra i due sia Margherita Belardetti ad avere radici svizzere, essendo nata a Sorengo (seppur vanti una lunga carriera formativa in Italia). Ma veniamo alle motivazioni che hanno che fare principalmente con le scelte stilistiche che possono apparire lievi, ma sono comunque in grado di cambiare l’impatto complessivo dell’opera.
Quai o lungofiume?
Tra queste, l’aspetto linguistico interviene anzitutto nella resa delle descrizioni. Un esempio che a noi risulta significativo – nel paragrafo preso quale modello – è l’uso del termine «quai», che nell’edizione di Spagnol mantiene la connotazione originaria, più vicina all’ambientazione suggerita da Dürrenmatt: ancora oggi nella lingua della svizzera italiana si predilige il termine usato da Spagnol, mentre il lungofiume ci rievoca semmai il lungomare, da noi poco in uso per ovvie ragioni; meglio, il lungolago, che però più spesso viene detto la riva. Nella nuova traduzione di Belardetti, di fatto, il termine lungofiume appare una scelta moderna e adatta a un pubblico italiano. Si potrebbe dire che ciò migliori l’accessibilità al testo grazie all’ambientazione più astratta e meno locale, tuttavia così facendo a noi sembra che corra il rischio di allontanare il lettore dall’atmosfera svizzera in cui si muovono i personaggi. Ugualmente accade con l’aggettivazione del fiume: nella vecchia traduzione, è descritto come «gonfio e fangoso», immagine che richiama alla mente i nostri fiumi in piena, i quali diventano tali con le grandi piogge. Nella versione di Belardetti, il fiume è semplicemente «color del fango», un’immagine meno concreta, che può sembrare più poetica ma che, al tempo stesso, perde il legame con la specificità elvetica, facendo venire alla mene il Tevere, per non dire il Gange, entrambi sempre di quel colore. Questo tipo di adattamento, di certo elegante, come detto contribuisce a una visione più universale, ma allontana dalla verosimiglianza geografica in cui è ambientata la narrazione.
Per non parlare dei parapetti: arrugginite possono essere al massimo le ringhiere, non certo i parapetti che risultano essere moderni, idealmente di acciaio, perché «moderna» risulta la parola nel nostro linguaggio locale, rispetto alle ringhiere. Questione di semantica, non di realtà oggettiva.
La resa della trama
Tralasciando altri dettagli di questo genere, è – in un certo senso – sulla resa della trama che si giocano però le differenze più sottili tra le due versioni. Greco cerca greca racconta la storia di Arnolph Archilochos, un uomo mediocre e ordinario, la cui vita prende una svolta inaspettata quando pubblica un annuncio per trovare moglie. La risposta arriva da Chloé Saloniki, una donna misteriosa che non solo sconvolge l’esistenza di Arnolph, ma smaschera la natura fittizia del suo «mondo consolidato». La trama, a metà tra il comico e il tragico, rivela un Dürrenmatt più che mai attento a scardinare i miti della borghesia, mettendo in discussione tutto ciò che sembra saldo e immutabile, compreso l’amore.
Nella traduzione di Spagnol, l’atmosfera di decadenza borghese è accentuata da un linguaggio che, anche nella sua semplicità, evoca con precisione l’immagine di una società ingessata nei suoi rituali e convenzioni. La nuova traduzione di Belardetti, invece, spinge piuttosto su un certo alleggerimento che, pure non perdendo il senso dell’umorismo o della satira, sfoca certe caratteristiche rendendole meno taglienti.
Non solo dettagli tipografici
In tal senso, uno degli interventi più significativi riguarda l’uso delle maiuscole, che in questo romanzo non sono semplici dettagli tipografici, ma veicolano l’ossessione del protagonista Archilochos per l’«Ordinamento morale del mondo», sottolineando la sua cieca idolatria nei confronti proprio di quel sistema sociale che Dürrenmatt non manca di demolire con feroce ironia. Nella versione di Belardetti, l’abolizione di molte maiuscole sembra alleggerire il testo, rendendolo più scorrevole, ma al contempo meno incisivo nella sua lettura allegorica.
Non da ultimo, nella descrizione della folla domenicale, la nuova traduzione dipinge un’immagine più caotica, con famiglie «accalcate» sui marciapiedi e nonni «parati a festa» con nipotini in «ghingheri» che, pur essendo un termine, quest’ultimo, a noi familiare, sembra adattarsi più al linguaggio popolare che alla borghesia zurighese, cui invece appartengono i «nonni solenni e i nipoti lindi» della traduzione precedente, che mette in «riga» le famiglie, ora sì ordinatamente svizzere, non solo secondo il nostro immaginario. Questo cambio di registro non è solo linguistico, ma come si vede può modificare la percezione del lettore sulla classe sociale di riferimento, spostando l’equilibrio della narrazione.
Fluidità o profondità?
Per concludere, la nuova traduzione di Margherita Belardetti rappresenta senza dubbio un contributo importante alla riscoperta di Greco cerca greca, portando l’opera di Dürrenmatt a un pubblico più ampio. Tuttavia, il confronto con la traduzione di Spagnol rivela come certe scelte stilistiche, apparentemente minime, condizionino l’interpretazione culturale delle scene. Certo: la satira del romanzo è feroce, e sia nella vecchia sia nella nuova traduzione emerge lo spirito dell’autore, sebbene con sfumature diverse. La vecchia traduzione trasmette una sensazione di maggiore «autenticità elvetica» attraverso dettagli che sembrano riecheggiare la Zurigo borghese di Dürrenmatt. Mario Spagnol era riuscito a preservare un rispetto quasi filologico per la struttura e l’immaginario dell’originale tedesco. Al contrario, la nuova traduzione sembra più orientata verso un pubblico italiano, con scelte linguistiche che, nonostante siano accurate ed eleganti, rischiano di attenuare e talvolta distorcere leggermente sia l’ironia sia la precisione dell’immaginario svizzero.
Chi conosce l’opera di Dürrenmatt e ne apprezza la sottigliezza ironica potrebbe dunque trovare nella traduzione di Spagnol un ancoraggio più forte al contesto culturale originario. In definitiva, entrambe le versioni offrono un valido accesso a Greco cerca greca, ma la scelta tra le due dipenderà da ciò che il lettore cerca: una lettura fluida e moderna, o un’immersione più profonda nel mondo borghese che Dürrenmatt amava così tanto ridicolizzare.








