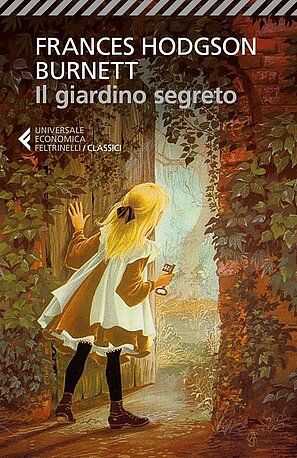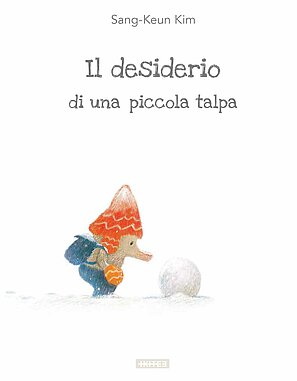Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Viale dei ciliegi
Letizia Bolzani
Frances Hodgson Burnett, Il giardino segreto, Feltrinelli (Da 9 anni)
Il 2024 se ne è volato via pressoché dimentico di due anniversari importanti. Forse perché donne, ma ancor più perché scrittrici per l’infanzia, quindi non di vera letteratura, com’è nell’inconcepibile pregiudizio di molti, due grandissime scrittrici sono state troppo poco ricordate. Eppure, l’occasione celebrativa c’era eccome: il 150esimo anniversario della nascita di Lucy Maud Montgomery (autrice, tra le altre sue opere pregevoli, della celebre saga di Anna dai capelli rossi) e il 100esimo anniversario della morte di Frances Hodgson Burnett (1849-1924). Sulla Montgomery torneremo, oggi vorrei concentrarmi sulla Burnett e in particolare sul suo capolavoro The Secret Garden.
Uscito nel 1910, dopo gli altrettanto incantevoli Il piccolo Lord e La piccola principessa, Il giardino segreto è un fulgido esempio di ciò che forse caratterizza più di tutto i grandi classici per l’infanzia, ossia la messa in scena del tema della soglia, come portale verso un Altrove salvifico, da cui si fa ritorno cambiati, con una consapevolezza nuova. Le case sull’albero, le isole che-non-ci-sono, le giungle misteriose, l’underground, gli armadi magici, le passa-porte, in molti romanzi ritroviamo il topos della soglia come passaggio verso il Trascendente, ma nel Giardino segreto esso diventa iconico, e verrà ripreso in tante opere successive. Il tema del giardino segreto, come luogo di guarigione e di rinascita, è una delle metafore più potenti della letteratura per l’infanzia. Il giardino segreto è tuttora un testo in grado di rendere perfettamente quel territorio di limbo, quel regno dell’altrove che l’infanzia predilige: un giardino segreto è il regno dell’immaginario, certo, ma è anche, più letteralmente, un luogo «terapeutico» dove coltivare e veder crescere, oltre le piante, anche i propri desideri. Il romanzo racconta di Mary, bambina orfana che giunge dall’India in Inghilterra, dallo zio. Mary è depressa e viziata e il giardino segreto che scopre, nel grande terreno dello zio, sarà salutare per lei: come i fiori e le piante di quello spazio chiuso e inaccessibile, anche lei rifiorirà. A infonderle energia vitale sarà, oltre al giardino, Dickon, un ragazzino della brughiera, un vero puro di cuore, in grado di «incantare piante e animali», a metà tra un angelo e un dio Pan. Non a caso la prima apparizione di Dickon è mentre suona il flauto, nel bosco.
Dopo essersi disintossicata dai pensieri negativi (la psicanalisi allora muoveva i primi passi, eppure la Burnett già scriveva «il pensiero possiede l’energia di una batteria elettrica, che per alcuni può essere salutare come la luce del sole, per altri nocivo come il veleno») Mary rifiorisce, e rifiorisce anche il cugino Colin, bambino ancor più depresso e nevrotico, autoconfinatosi nel chiuso della sua stanza. Ecco che il giardino segreto diventa un luogo simbolico di guarigione, un luogo dell’anima, e soprattutto un Altrove riservato all’infanzia, nel quale gli adulti non possono accedere. Anche per Colin vivere con dei coetanei e lavorare la terra, assaporando il ritmo della natura, equivale a riaccendere nell’anima una fiammella vitale. E insieme ai bambini rinasce il giardino.
Sang-Keun Kim, Il desiderio di una piccola talpa, Kite (Da 4 anni)
Un paesaggio innevato e una palla di neve campeggiano nelle pagine di questa delicata storia dell’autore coreano Sang-Keun Kim, ma la palla di neve è personificata dalla prospettiva della piccola talpa protagonista. È, questo, un perfetto esempio di animismo infantile, il quale dà un’anima all’inanimato, e quindi una palla di neve può diventare un’amica con cui aspettare l’autobus. Ma gli autisti dei vari autobus, che uno dopo l’altro passano dalla fermata, sono degli adulti e non hanno più la capacità di vedere il magico del quotidiano: «come sarebbe a dire una tua amica? È neve e basta… e quindi è destinata a scomparire». La prospettiva adulta contro la prospettiva magica dell’infanzia, in una storia tenuta magistralmente dal punto di vista di talpa, perché la palla di neve non è oggettivamente animata, e infatti essa «ascolta, ma non dice nulla». Eppure, contro ogni previsione degli autisti degli autobus, palla di neve non scomparirà, o almeno non nella prospettiva di talpa, e il bellissimo finale ci confermerà la possibilità di scorgere un mondo in cui, se lo desideri, tutto è possibile.