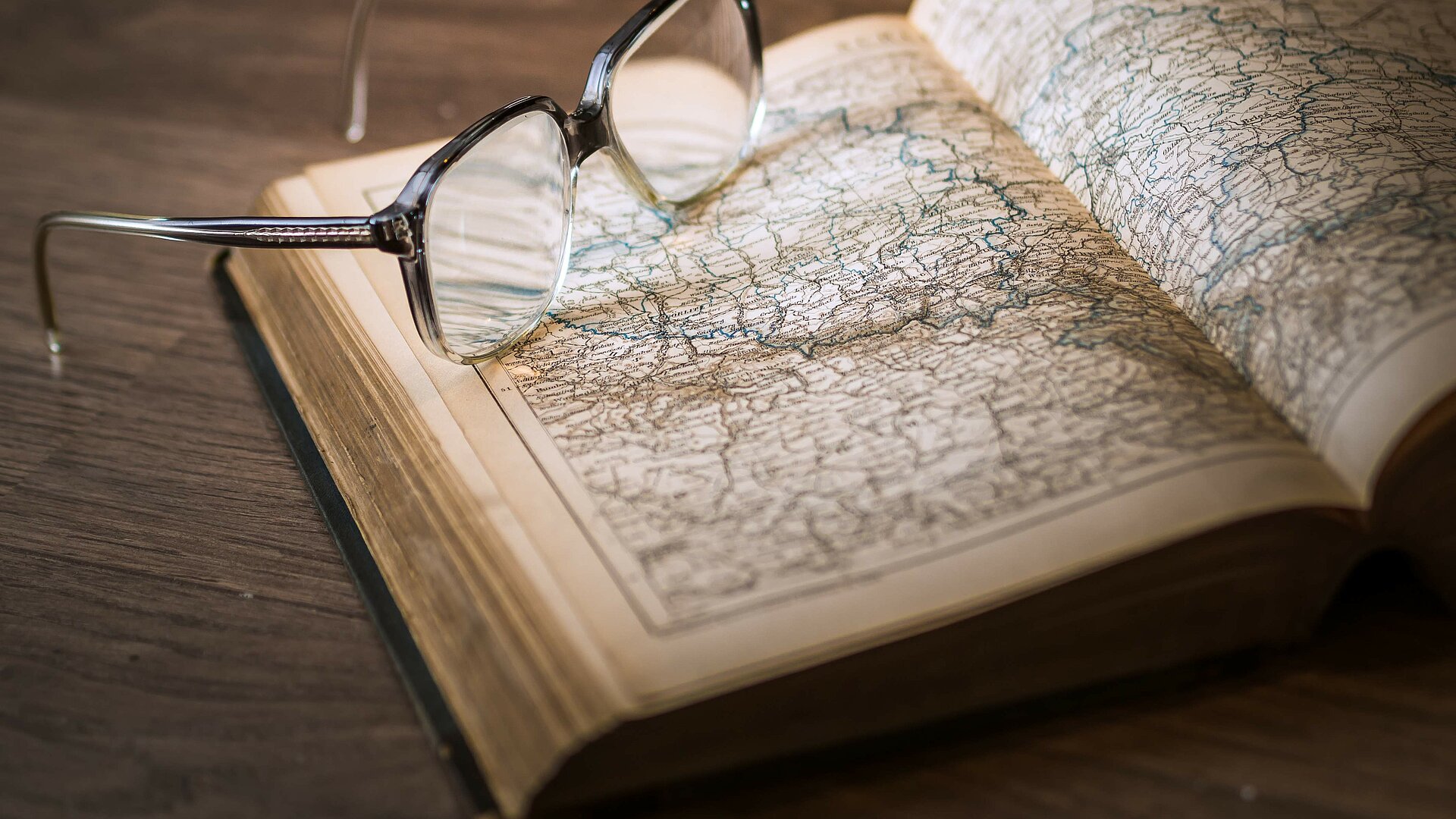Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
La geografia come sapere e come cura
Claudio Ferrata prende posizione in difesa di quella che è, tra le altre cose, una scienza utile per costruire il bene comune
Orazio Martinetti
Una dichiarazione di amore per la geografia: è questo il sentimento che sorregge l’ultimo saggio di Claudio Ferrata, a lungo docente di geografia nei licei e tuttora cultore della materia, nonché membro del Comitato direttivo dell’Associazione GEA. L’autore ha condensato le sue osservazioni in un breve (un centinaio di pagine) ma denso libretto, sotto il titolo Scrivere la terra. La geografia, sapere sullo spazio e azione sul mondo, edito da Mimesis. In realtà Ferrata, per esprimere la sua relazione con la disciplina che ha sempre coltivato con passione, ricorre all’espressione «presa di posizione per la geografia!». Il punto esclamativo non è casuale, manifesta la ferma volontà di difendere un campo di studio che, al pari di altre scienze sociali, si ritrova spesso nella condizione, un po’ umiliante, di giustificare la sua presenza e la sua utilità, e non soltanto nei programmi scolastici. Eppure tutti vestiamo i panni del geografo nel nostro modo di rapportarci con il mondo esterno, quando scegliamo un’ubicazione in cui abitare, quando calcoliamo i tempi di percorrenza casa-lavoro, quando intraprendiamo una gita o un viaggio, o percorriamo un sentiero di montagna affidandoci alle carte topografiche.
Come altre discipline che le stanno vicine – la sociologia, la storia, l’antropologia culturale – la geografia ha conosciuto un enorme sviluppo dopo la Seconda guerra mondiale, in concomitanza con i processi di decolonizzazione e i progetti di aiuto allo sviluppo. A lungo identificata con un freddo nozionismo fatto di classificazioni e nomenclature, specie nell’insegnamento, la geografia postbellica ha allargato gli orizzonti, dialogando con le scienze sociali e umane. Nel 1968 uno dei padri di questo nuovo indirizzo, il francese Pierre George, dava alle stampe L’Action humaine in cui proponeva la seguente definizione: «Si potrebbe definire la geografia come lo studio della dinamica dello spazio umanizzato». Da allora i confini disciplinari si sono estesi fino ad incrociare l’urbanistica, la demografia, le scelte politiche, la tutela del paesaggio e del patrimonio naturalistico. Concetti con «luogo», «spazio», «territorio», «regione» hanno assunto significati nuovi, aperti alle contaminazioni. Si pensi a come viviamo/interpretiamo la nozione di «luogo», le cui radici fisiche, materialmente delimitate, arrivano a toccare le corde delle emozioni e dell’appartenenza. Sono i luoghi del cuore, ricordi che risalgono all’infanzia, oppure ad improvvise accensioni della memoria di fronte ad uno scorcio suggestivo, ai pregi architettonici di un edificio storico, ai colori di un tramonto alpino, alla vegetazione di un parco cittadino. Insomma, avverte l’autore a p. 89, la geografia «produce una conoscenza inerente alle relazioni con lo spazio ed è implicata nei progetti sociali, aperta sulle tematiche ambientali, su tutto ciò che riguarda la nostra presenza nei territori». Da questo approccio sono nate, nel recente passato, visioni come la «città-Ticino», con una doppia valenza. Per un verso la presa d’atto che il Cantone era diventato sempre più un grumo unico urbano, concentrato nei fondivalle, solcato da arterie viarie e ferroviarie interconnesse; per l’altro la necessità di governare questa conurbazione in costante espansione tentacolare con gli strumenti della progettazione e della pianificazione. Impresa che ha richiesto il contributo anche dei geografi, accanto ai geologi, agli architetti, agli urbanisti, agli ingegneri del traffico…
Questo saggio di Ferrata vuol essere una «peroratio» in favore della materia che ha insegnato per tanti anni. E anche un omaggio a maestri come Lucio Gambi, Claude Raffestin, Eugenio Turri, Franco Farinelli… Infine l’autore pensa ai giovani, gli ideali destinatari di questo trattatello, per dire che la geografia è molte cose assieme: un sapere riflessivo ma anche una scienza utile per costruire il bene comune, dotata di applicazioni che vanno dalla cartografia (oggi prevalentemente digitale) all’approntamento delle «cure» di cui hanno urgente bisogno i nostri territori sempre più malati.