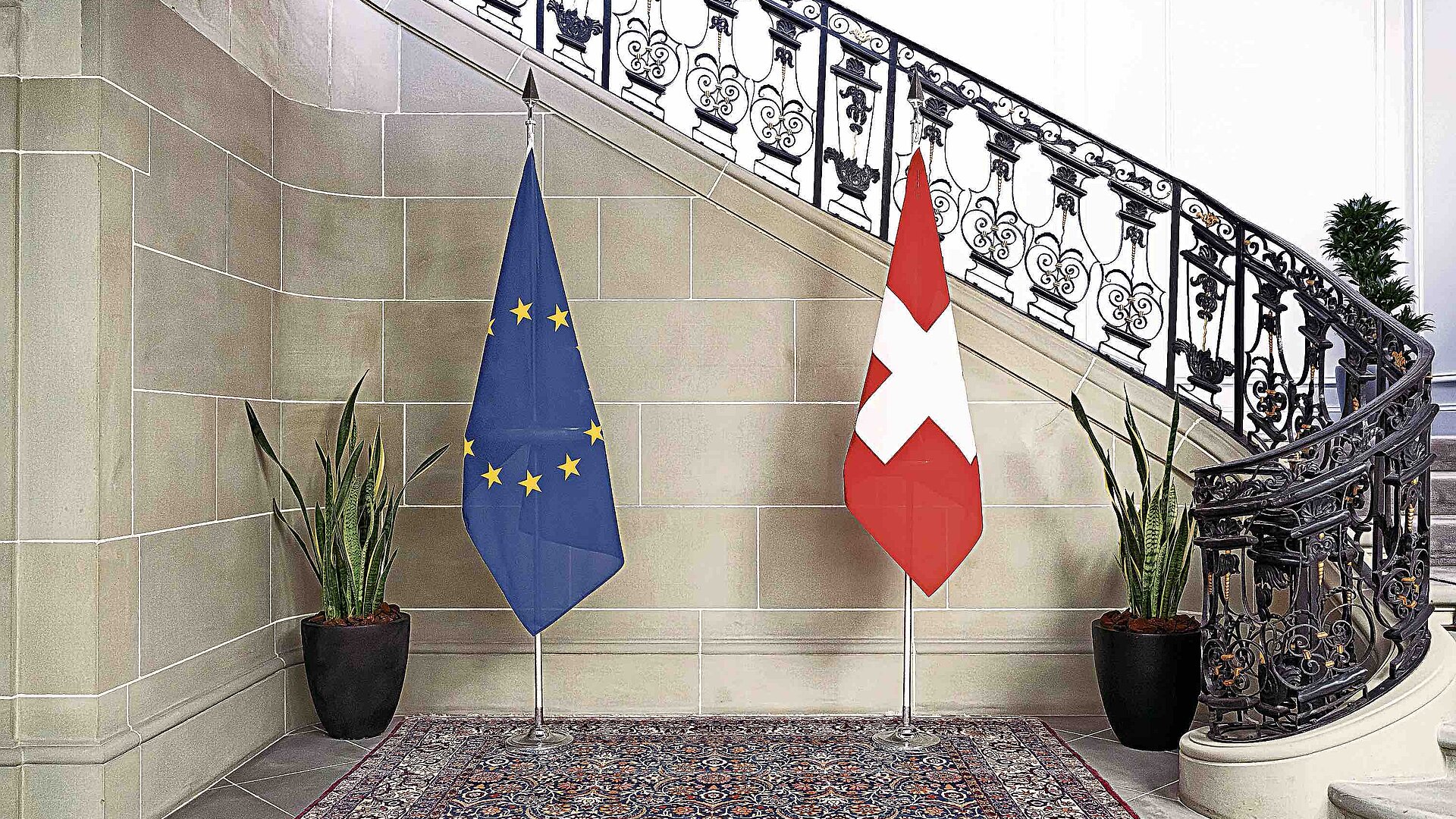Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Un passo in direzione dell’Europa
Berna ha riaperto la strada per il consolidamento della via bilaterale. Le difficoltà che gravano sul futuro negoziato
Marzio Rigonalli
Dopo quasi tre anni dalla rottura del negoziato bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea, il Consiglio federale ha deciso di riaprire la strada che un giorno potrebbe portare al consolidamento della via bilaterale. Nella riunione dello scorso 8 novembre ha incaricato il Dipartimento degli affari esteri di preparare un progetto di mandato negoziale, in vista di un possibile nuovo accordo. La decisione è arrivata dopo una decina di colloqui esplorativi avvenuti tra Berna e Bruxelles, in gran parte condotti dalla segretaria di stato Livia Leu e, infine, dal suo successore Alexandre Fasel. L’ultimo colloquio esplorativo è avvenuto il 27 ottobre. Il Governo federale ha ritenuto soddisfacenti, o per lo meno sufficienti, i risultati di questi colloqui per poter andare oltre. Se verrà approvato, il mandato negoziale avvierà una lunga procedura. Alla fine dell’anno verrà esaminato dalle commissioni parlamentari di politica estera e dalla conferenza dei Governi cantonali. Anche la Commissione europea preparerà un mandato negoziale sulla base delle indicazioni che riceverà dai Governi dei 27 Stati membri.
Siamo alla soglia del 2024, un anno importante per la politica europea. A giugno ci saranno le elezioni del nuovo Parlamento e subito dopo verrà nominata una nuova Commissione. Oggi è difficile prevedere quando comincerà il negoziato bilaterale, a che ritmo procederà e chi saranno i protagonisti. Un risultato concreto l’avremo probabilmente soltanto nel 2025 o nel 2026. Sono scadenze lontane e alle quali bisognerà ancora aggiungere un altro anno per consentire lo svolgimento delle procedure interne di accettazione, sia in Svizzera, con l’ultima tappa del voto popolare, sia nei Parlamenti dei Paesi europei.
Diversi sono i temi che caratterizzeranno il futuro negoziato. Innanzitutto occorrerà trovare soluzioni istituzionali agli accordi esistenti sull’accesso al mercato unico, sia per quanto concerne la ripresa del diritto europeo che per il superamento di eventuali divergenze d’interpretazione. Trattasi, in particolare, degli accordi sulla libera circolazione delle persone, sull’agricoltura e sui trasporti terrestri ed aerei. Poi, dando seguito alla volontà della Svizzera, bisognerà cercare di concludere nuovi accordi nei settori dell’energia elettrica, della sicurezza alimentare e della salute. Quindi la Svizzera cercherà di ottenere di poter di nuovo partecipare a Horizon Europe, il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027. È un programma che ha una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di euro. Pur avendo abbandonato l’Ue, la Gran Bretagna è stata riammessa in questo programma. Infine, occorrerà affrontare problemi che incontrano una forte opposizione in alcuni settori della società svizzera, come per esempio la protezione dei salari del personale distaccato in Svizzera, o l’applicazione della direttiva relativa al diritto dei cittadini europei e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Per coronare il tutto, ci si dovrà accordare anche sull’importo annuale che la Svizzera, come ha già avuto modo di promettere, verserà all’Unione europea per aiutarla nel suo sviluppo e nella sua coesione interna.
È un programma molto ricco, dietro al quale si nasconde un braccio di ferro riassumibile in due distinte domande: quanta sovranità la Svizzera è disposta a cedere per potersi garantire la via bilaterale e quindi l’accesso al mercato unico europeo in svariati settori? E quante concessioni l’Ue è disposta a fare alla Svizzera, che non è uno stato membro dell’Unione, senza creare una situazione privilegiata che potrebbe nuocere agli interessi degli Stati membri, o che potrebbe semplicemente essere in contrasto con la situazione interna dell’Unione? Sarà un braccio di ferro presente durante tutto il negoziato, ma che può essere attutito dall’interesse delle due parti a raggiungere un accordo. L’Unione europea vuole preservare buoni rapporti con un partner economico importante. La Svizzera cerca di mantenere buone relazioni con i Paesi europei, soprattutto con quelli che la circondano, nonché di difendere l’ottima salute della sua economia. Quasi il 60% delle nostre esportazioni finisce nell’Ue e le principali organizzazioni economiche, Economiesuisse, l’Unione svizzera degli imprenditori e l’Unione svizzera delle arti e mestieri, sono favorevoli ad un accordo e hanno accolto positivamente la notizia del mandato negoziale. Più critici, invece, sono stati i sindacati, ma soltanto su alcuni punti in discussione. La loro posizione si concentra soprattutto sulla protezione dei salari. Ancora più critica è stata l’UDC. Come è noto, il primo partito svizzero è contrario a un accordo con l’Ue.
Nonostante gli ostacoli e le difficoltà che gravano sul futuro negoziato, l’apertura sul mandato negoziale rappresenta una nota positiva, un nuovo inizio nel dossier Europa e, nello stesso tempo, un successo per Ignazio Cassis. Il capo del Dipartimento degli affari esteri ha riportato al tavolo negoziale sia l’Ue, che ha digerito male la rottura del negoziato nel 2021, sia il Consiglio federale, le cui divergenze interne sull’Europa sono ben note. È anche un primo passo importante in un contesto internazionale che non è favorevole alla Svizzera. Una volta la Confederazione era rispettata e veniva spesso sollecitata per i suoi buoni uffici. Oggi le critiche contro la Svizzera arrivano da più parti. Dalla Russia, per le sanzioni europee riprese dal Consiglio federale; dagli Stati Uniti, che vorrebbero un intervento più energico contro le ricchezze dei gerarchi russi; dalla Cina, per ragioni economiche; dai Paesi alleati dell’Ucraina, per il blocco elvetico all’esportazione di armi e munizioni al Paese aggredito. Nella situazione attuale diventa difficile immaginare una situazione conflittuale nella quale la Svizzera potrebbe offrire i suoi buoni uffici con qualche possibilità di successo. Altri Paesi, non necessariamente neutrali, riescono meglio a guidare, o perlomeno a coordinare, una mediazione in regioni alle prese con conflitti. Anche per queste ragioni l’inizio del negoziato bilaterale, e ancor di più la conclusione di un accordo, potrebbero dare un po’ di certezza e un po’ di prestigio alla posizione della Svizzera in Europa e nel mondo.