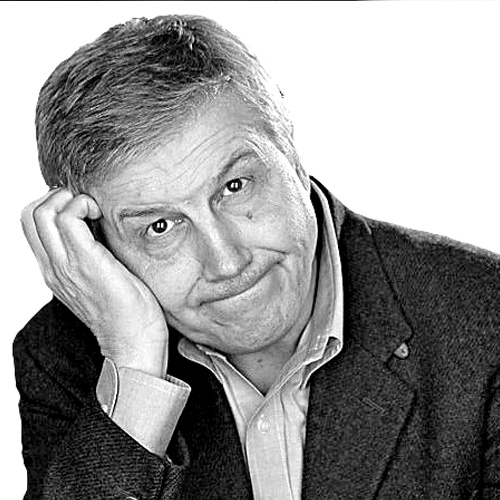Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
L’intelligenza artificiale e il pensiero critico
Aldo Grasso
Sarà vero che l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) per risolvere i nostri problemi influirà sul nostro pensiero critico? Impigrendosi, non più sollecitato a confrontarsi con il difficile e l’imprevisto, il nostro cervello non evolverà più e sarà prigioniero delle «macchine»?
Se la domanda la poniamo all’IA (ChatGpt ) veniamo rassicurati: «L’intelligenza artificiale può avere un impatto sul pensiero critico, ma dipende da come viene utilizzata. Se ci affidiamo troppo all’IA per prendere decisioni, risolvere problemi o rispondere a domande, possiamo rischiare di ridurre la nostra capacità di pensare autonomamente e criticamente. L’IA, infatti, è progettata per analizzare enormi quantità di dati e offrire risposte rapide, ma non sempre è in grado di considerare tutte le sfumature, i contesti o le implicazioni morali di una situazione, come farebbe un essere umano che esercita il pensiero critico. D’altra parte, se usata in modo consapevole e complementare, l’IA può anche stimolare il pensiero critico, offrendoci nuove informazioni, prospettive e strumenti per analizzare problemi in maniera più approfondita. È fondamentale che le persone sviluppino abilità di discernimento e imparino a utilizzare l’IA in modo consapevole, chiedendosi sempre se le risposte fornite dall’IA sono complete e veritiere, e se rispecchiano un’analisi approfondita». In sintesi, l’IA non erode il pensiero critico di per sé, ma, se non usata con attenzione, potrebbe renderci meno inclini a mettere in discussione ciò che ci viene presentato. È la classica risposta di buon senso, che ricalca quelle date nel corso degli anni, fin dai tempi della nascita della scrittura, a chi temeva che l’evoluzione tecnologica avrebbe svigorito la nostra capacità di pensare autonomamente e in maniera critica. Però…
C’è sempre un però, questa volta sotto forma di una relazione presentata da Microsoft e Carnegie Mellon nel corso dell’ultima edizione della più importante conferenza internazionale che si svolge annualmente sui temi della Interazione Umano-Macchina, CHI 2025, e che ha coinvolto 319 lavoratori della conoscenza (knowledge workers), quali professionisti dell’informazione, creativi, insegnanti, sviluppatori, chiedendo loro come e quando utilizzano strumenti di IA generativa come ChatGpt, Copilot o Dall-e.
Ne riferisce Federico Cabitza, professore associato di Interazione Uomo-Macchina all’Università di Milano-Bicocca: «Sebbene queste nuove modalità possano sembrare un progresso, in realtà presentano anche qualche lato oscuro. Il rischio è che, nel tempo, la nostra capacità di risoluzione dei problemi si possa come atrofizzare, come conseguenza di un fenomeno che gli esperti chiamano cognitive offloading, trasferimento cognitivo, ovvero la delega sempre maggiore delle attività mentali a uno strumento esterno. Questo è tutt’altro che un fenomeno nuovo: è noto che le calcolatrici abbiano atrofizzato le nostre capacità di calcolo mentale, i navigatori satellitari le nostre capacità di orientamento, e i motori di ricerca un certo tipo di memoria dichiarativa (il cosiddetto effetto Google). È lecito chiedersi cosa possa capitare alla nostra capacità di argomentare, di confrontare fonti, di pensare in modo originale se ci abituiamo a ricevere risposte pronte e ben formulate. Questo può avere ripercussioni ancora maggiori in quei contesti professionali dove l’expertise umana è considerata preziosa e necessaria, come la medicina o altre professioni liberali, in cui si ritiene che anni di studi e pratica siano necessari per raggiungere e mantenere un livello di prestazioni accettabile». Le questioni etiche e legali legate all’uso di questa tecnologia in ambito scientifico – e non solo – non si contano sulle dita di due mani: succede sempre così, quando una tecnologia innovativa, dalle numerose funzionalità e aperta a un vasto ventaglio di utilizzi, irrompe nella nostra vita quotidiana.
Siamo di fronte a un bivio esistenziale. L’IA conquisterà spazi sempre maggiori che oggi sono ancora occupati dalle nostre personali attività cerebrali e dalle nostre già bistrattate facoltà mentali. Più si delegano a un dispositivo meccanico le attività della mente e più la mente impigrisce fino a tendere all’atrofia. L’automazione non diminuisce, aumenta l’alienazione. Nonostante la fatica sprecata, un individuo che guida un’automobile è più libero di uno che ne è guidato. Oppure, come suggerisce Federico Cabitza e come c’è da augurarsi, andremo incontro a una trasformazione del ruolo cognitivo dell’essere umano. Il lavoro intellettuale non scomparirà, ma si sposterà su un altro livello, quello in cui da esecutori diventiamo supervisori.