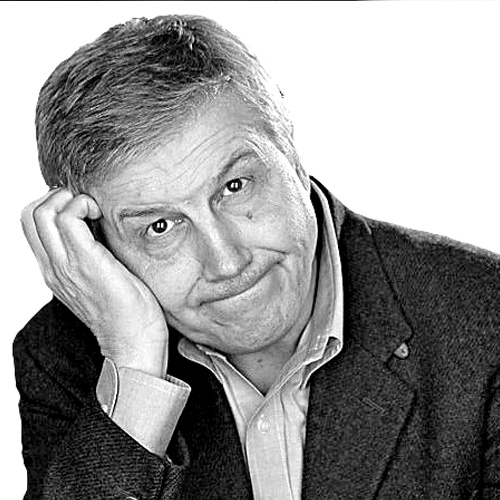Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!
Milano e il suo Genius Loci
Aldo Grasso
Quando si parla di Genius Loci si ignora, generalmente, il significato originario di questa strana e affascinante locuzione. Essa viene per lo più usata come una metafora, da architetti e, in particolare, da architetti paesaggisti per definire l’identità di un luogo, sia esso urbano o extraurbano. Rare sono le sue tracce in opere letterarie o in saggi estetici e filosofici. Tutto questo non scioglie l’enigma su quale sia, in effetti, il significato originario di Genius Loci.
L’origine del termine si rintraccia nell’antica religione romana dove si credeva che ogni luogo avesse uno spirito o una divinità che ne custodisse l’essenza. Di fatto, la parola genius indicava una forza soprannaturale, un’entità – anzi, un dio – che tutelava la forza generativa di ogni uomo; il significato si sarebbe poi ampliato fino ad attribuire al genius la facoltà di rappresentare l’essenza stessa dell’individuo. Il genius veniva quindi identificato come il protettore e il custode del luogo («loci») che, si riteneva, avesse un forte potere di influenza su eventi e persone.
Ho pensato a lungo a questa espressione visitando alle Gallerie d’Italia di Milano la mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti, Paola Zatti (c’è un bellissimo catalogo edito da Skira).
Qui, il Genius Loci è rintracciabile in almeno tre immagini simbolo. La prima che ci viene incontro è l’opera senza fine del Duomo. La decisione di partire a raccontare il genio di Milano dal Duomo è pertinente, poiché questa impresa, continuata per secoli, può essere elevata a paradigma della storia artistica, culturale e sociale della capitale morale d’Italia. Milano è una città indaffarata e operosa, così come l’hanno raccontata grandi scrittori come Stendhal, Carlo Dossi, Carlo Porta, Delio Tessa, Carlo Emilio Gadda che ci hanno regalato scorci milanesi di rara suggestione e mobilità. Milano, diceva con impeccabile maestria Alberto Savinio, è una robusta, onesta stoffa su cui ricamare divagazioni, Milano si presenta come «città tutta pietra in apparenza e dura mentre è morbida di giardini interni».
La seconda immagine è il quadro di Giuseppe Diotti che si chiama La corte di Ludovico il Moro. Non sono un critico d’arte, ma visitando la mostra è impossibile non soffermarsi davanti a questo quadro, anche per la sua grandezza, tale da occupare un’intera parete. Siamo a Milano, verso la fine del Quattrocento: accanto al duca sono seduti la moglie Beatrice d’Este e il fratello, il Cardinale Ascanio Sforza, mentre intorno a loro, oltre a Leonardo da Vinci, sono riconoscibili i grandi personaggi del mondo della cultura che frequentavano abitualmente la corte milanese: l’architetto Bramante, il matematico Frate Luca Pacioli, il musicista Franchino Gaffurio, il poeta Bernardo Bellincioni, lo storico Bernardino Corio, che reca sotto braccio un libro della Storia di Milano. Ecco, Milano non ha mai avuto paura ad affidarsi ai migliori, a creare cenacoli di intelligenza e creatività, a riconoscere il ruolo fondamentale del mecenatismo, ieri come oggi, anche se sotto forme diverse.
Infine, la terza immagine è la più frantumata, la più sminuzzata, le cui tessere costituiscono un mosaico sparso un po’ ovunque e riguarda, seguendo la definizione dei curatori della mostra, i cosiddetti «foresti». Il genio di Milano è un genio composito, un genio plurale: Milano ha sempre accettato i «foresti»: prima gli immigrati dal contado, poi quelli che provenivano dal resto dell’Italia e dall’estero per trovare un lavoro e per fare grande la città. Un apporto che ha conosciuto un susseguirsi di migranti eccellenti – primi fra tutti Leonardo e Bramante – fino all’immigrazione vera e propria nella seconda metà del Novecento, un contributo fatto di pragmatismo ed efficienza.
A caratterizzare il fervore dello «stile milanese» è anche l’attività manifatturiera e poi industriale che si sviluppa dopo la fine del Risorgimento, raccontato efficacemente nel romanzo Cento anni (1859) dello «scapigliato» Giuseppe Rovani. La mostra si chiude con il futurismo di Boccioni, che implode nel Novecento di Mario Sironi, arrivato da Roma per incontrare la malinconia delle periferie, e l’avanguardia imprevista di Melotti e Fontana, ultimi interpreti del Genius Loci.