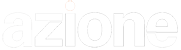Donald Trump non è affatto un isolazionista. Interviene eccome all’estero. «America first» non significa che l’America si occupa solo di sé stessa. Al contrario, significa privilegiare e se necessario imporre gli interessi americani agli altri. Prendiamo l’intervento in Venezuela e l’arresto di Nicolas Maduro. La lotta al narcotraffico, invocata come pretesto, non c’entra niente. E il petrolio venezuelano, su cui l’America intende mettere le mani, non spiega tutto. Trump ha voluto chiaramente dire: il Continente americano è roba nostra. Non della Cina, non della Russia; nostra. Non a caso ha colpito quando era ancora in territorio venezuelano una delegazione cinese.
Più che alla dottrina Monroe – il presidente Usa che nel 1823 sostenne che non avrebbe più tollerato interferenze europee nel Continente americano – il riferimento storico corretto è alla «politica delle cannoniere» di Theodore Roosevelt, che teorizzava l’esigenza di fare politica con un «big stick», un grosso bastone. Forse non tutti ricordano che Panama era parte della Colombia, da cui fu staccata con la forza e con i dollari degli americani, che negli stessi anni occuparono militarmente El Salvador e discutevano se annettere Cuba. Non abbiamo nostalgia dei golpe degli anni Settanta del Novecento con cui Henry Kissinger abbandonò la gioventù cilena e argentina nelle mani dei torturatori; ma se non altro la sovranità formalmente restava in mani locali. Trump riporta le lancette della storia indietro di oltre un secolo. E il bello è che Roosevelt ricevette comunque il Nobel per la pace, nel 1906, per aver mediato tra russi e giapponesi. Vedremo cosa saprà fare Trump tra russi e ucraini.
Quello che è accaduto a Caracas ripropone poi un’antica discussione. È lecito usare la forza contro i tiranni? Occorre una premessa, anzi ne occorrono tre. Il Venezuela di Maduro è una democrazia? No. Maduro ha governato bene, per la libertà e la prosperità del suo popolo? No. Rimpiangeremo Maduro? No. Fatte queste premesse, dobbiamo chiederci perché il regime, decapitato, non si è sciolto come neve al sole, anzi, al potere ora c’è la vice di Maduro, e le strade di Caracas sono piene di folle che inneggiano al dittatore deposto. Trump fa notare che sono manifestanti brutti, male in arnese, probabilmente pagati. Però ci sono. Perché ogni regime, anche il peggiore, ha sempre una base di consenso. Ha sempre dei beneficiati. E ha sempre un apparato di repressione. In giro per Caracas non ci sono soltanto manifestanti, ma anche miliziani incappucciati, che danno la caccia ai «traditori» accusati di aver aiutato gli americani. Proprio come accade in Iran. A volte l’alternativa a un regime è un altro regime. E ci si illude di poter cambiare un dittatore con un altro, però amico nostro, dell’Occidente: ad esempio c’è gente che pensa di sostituire gli ayatollah con il figlio dello Scià. La realtà è che la democrazia è in ritirata in mezzo mondo. Neppure noi occidentali ci crediamo più sino in fondo. Occorre molto ottimismo per pensare che ci credano venezuelani e iraniani; anche se abbiamo il dovere di sostenere i pochi o i tanti che ci credono.
George Bush junior parlava di esportazione della democrazia: non ha funzionato, né in Afghanistan né in Iraq. Trump non ci prova neppure. Non intende portare la democrazia a Caracas. Libere elezioni sono sempre un rischio. Si pensi a quel che è accaduto in Egitto: la piazza ha deposto Mubarak, generale amico dell’Occidente; alle elezioni ha vinto Morsi, il candidato dei Fratelli musulmani, antioccidentale; è seguito un colpo di Stato che ha ripristinato la dittatura militare, affidata alle mani di Al Sisi, più dure di quelle di Mubarak. A Caracas Trump intende dialogare con i pezzi di regime più disposti a collaborare con gli Usa. Non intende liberare i venezuelani, consentire loro di scegliersi un leader; intende sottrarre il Venezuela all’influenza della Cina, della Russia, degli avversari degli Stati Uniti d’America. Poi certo una parte del suo movimento rimprovera a Trump di impicciarsi troppo negli affari internazionali e di trascurare le vicende interne. A novembre, alle elezioni di midterm, la sua leadership è a rischio: Trump potrebbe perdere il controllo del Congresso. Ma gli Usa restano non solo la più grande democrazia; restano la prima potenza economica mondiale. Una democrazia capitalista, dove si vota sui prezzi, sui salari, sull’occupazione. E sulle tasse. In questo, Trump rimane nella percezione degli americani più affidabile dei democratici.