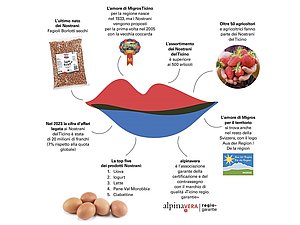MONDO MIGROS
Di donne per donne, ma non solodi Redazione
Forum elle è una piattaforma di scambio femminile apartitica, aconfessionale e indipendente. Attraverso un’offerta di eventi regionali e interregionali si rivolge in prima linea a donne che sono convinte dei valori, delle attività e del knowhow di Migros. E questo sin dal 1957. …





![MAHKU, Kapewe Pukeni [Bridgealligator], 2024, Site-specific installation](/fileadmin/multimedia/_processed_/2/2/csm_MDM_MAHKU-131_Ph_by_Matteo_De_Mayda_513d40716b.jpg)