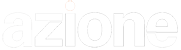Sono passati dieci anni dalla vittoria della Brexit nel referendum del giugno del 2016. In questo periodo, allora, il Governo dell’ex premier David Cameron aveva negoziato un accordo con l’Ue che, nelle intenzioni, stabiliva ulteriori concessioni al Regno Unito (nei 40 anni che ha passato dentro la comunità europea ha sempre avuto una posizione privilegiata) e scongiurava la possibilità che i britannici votassero a favore dell’uscita dall’Unione. Si pensava di replicare quel che era accaduto l’anno precedente con il referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno: certo che gli scozzesi sono nel cuore indipendentisti, proprio come gli inglesi sono euroscettici, ma poi ci sono la convenienza, il portafoglio, la solidità, il raziocinio…
Dieci anni dopo quel referendum in cui invece fantasie e propaganda (e una campagna miratissima dei brexiteer, con ingerenze russe) ebbero il sopravvento, il Governo dell’attuale premier, il laburista Keir Starmer, sta cercando di fare tutto il possibile per riavvicinare il Regno all’Ue, tentando di non dare troppo nell’occhio e ripetendo che il divorzio c’è e resterà, solo si tratta di ammorbidirne le condizioni. Nel 2024, appena eletto dopo 14 anni di dominio conservatore (i Tories hanno pensato la Brexit, cercato di evitarla, l’hanno votata e malgestista), Starmer ha annunciato un «reset» dei legami commerciali ed economici tra Londra e Bruxelles, muovendosi in modo cauto. Di recente ha accennato al desiderio di allineare il Regno al mercato unico europeo, cosa quasi «indicibile» ma necessaria perché l’economia britannica è claudicante e tutto il mondo è influenzato dal protezionismo americano e da una politica dei dazi capricciosa, imprevedibile. I colloqui anglo-europei sulla riduzione dei controlli e delle barriere commerciali sono sempre più intensi. La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves e i responsabili del commercio e dell’economia dell’Ue, Maros Sefcovic e Valdis Dombrovskis, si sono incontrati e hanno lanciato messaggi rassicuranti anche sull’impegno per la reintegrazione del Regno Unito nell’unione doganale, un altro tabù che via via sta crollando.
I sorrisi che i negoziatori ostentano non devono però confonderci. L’urgenza del «reset» di Starmer è con tutta probabilità genuina, ma il calcolo è più complicato di così. Da un lato c’è la leadership del premier, che è sotto gli attacchi interni al Labour (ora in particolare a causa di Peter Mandelson e dei suoi legami con Jeffrey Epstein), ma che soprattutto è appesa alle elezioni amministrative che si terranno a maggio e potrebbero sancire il consolidamento di Reform Uk come primo partito del Paese. Reform Uk è l’ultima creatura di Nigel Farage, primo sostenitore della Brexit: aveva le idee chiare sul divorzio necessario ma nessuna proposta concreta per gestirlo. Però, come accade a parecchi altri leader nazionalisti e populisti, quel gran fallimento che è stata la Brexit sembra non intaccarlo. Farage è riuscito a trasformarsi nel candidato anti-sistema – lui che l’ha sfasciato, il sistema – e a rosicchiare voti dal Partito conservatore. L’ascesa di Farage sta influenzando le scelte di Starmer, ma non è l’unico fattore.
Il Regno Unito deve trovare un equilibrio tra il riavvicinamento all’Europa e l’ostilità di Donald Trump, che finora non si è espressa con tutta la sua forza ma resta presente. Un esempio è la sospensione del grande accordo sull’Intelligenza artificiale dedicato alla «prosperità» reciproca, firmato da Trump e Starmer durante la visita del presidente americano nel Regno Unito: gli Usa, soprattutto Elon Musk, accusano Londra di censurare la rete. Ci sono stati anche altri dispetti da parte di Trump; il più grave è l’accusa agli alleati di essere stati codardi in Afghanistan e di aver combattuto dalle retrovie. Gli inglesi hanno chiesto scuse pubbliche, ricordando che quasi 500 soldati britannici sono morti in Afghanistan dopo l’11 settembre, nell’unica occasione in cui gli Stati Uniti hanno invocato l’articolo 5 della Nato che prevede il mutuo soccorso.
Starmer si muove tra Europa e Stati Uniti, e come altri Paesi atlantisti cerca una compensazione corteggiando la Cina. È andato a Pechino portando in dono l’approvazione della grande ambasciata cinese nell’ex palazzo della Zecca a Londra, un progetto contestato perché considerato da molti esperti un futuro covo di spie. Nonostante questa concessione politicamente esplosiva, Starmer non è stato trattato bene: i cinesi non hanno nemmeno chiuso la Città proibita durante la sua visita e non lo hanno accompagnato, lasciandolo con una semplice guida. E non è tornato a casa con accordi significativi. Poco e male, insomma.