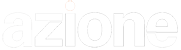In che modo i media tradizionali e i social media peggiorano le possibilità di dialogo su temi spinosi come il conflitto a Gaza? Bella domanda, penso, leggendola nella lista preparata dal comitato degli studenti del liceo di Locarno per la Giornata per la Palestina, organizzata qualche settimana fa. Bella e paradossale, perché l’ultima cosa che si dovrebbe pensare dei giornali è che, invece di spiegare in parole semplici le situazioni ingarbugliate del pianeta, «peggiorino le possibilità di dialogo».
Al netto delle litigate fra opinionisti in diretta TV durante i talk show, il buon giornalismo resta l’ultima barriera contro la disinformazione. È proprio su questo punto che va tracciata una netta linea di separazione tra media tradizionali e social media.
Nei media tradizionali, infatti, dovrebbero valere i tre pilastri della buona informazione: ricerca della verità, indipendenza di giudizio e rispetto delle persone.
Si può discutere su quanto questi principi vengano effettivamente rispettati dai professionisti dell’informazione negli scenari di guerra (e non solo), ma se un giornalista li disattende scientemente, tradisce la propria coscienza professionale.
Al di là delle linee editoriali, lo scopo ultimo dell’informazione, inscritto nel suo DNA, resta quello di avvicinarsi il più possibile ai fatti reali, senza essere influenzata da posizioni ideologiche o da lobby, e rispettando la dignità delle persone di cui si riferisce. Se parliamo di media tradizionali, questo è il minimo che dovremmo aspettarci: che i fatti vengano verificati il più e il meglio possibile, che le fonti siano sempre citate in modo chiaro e che la descrizione degli avvenimenti sia nitidamente separata dalle opinioni (attraverso le quali si manifesta la linea della testata).
I social media, invece, sono ruffiani e piacioni: vogliono divertire chi li usa, lusingarlo, intrattenerlo e, soprattutto, raccogliere dati sui suoi desideri per proporgli a colpo sicuro qualcosa da comprare.
Se i media tradizionali veicolano la realtà, i social media vendono desideri. Sul piano dell’informazione, la quantità di click conta molto più dell’esattezza dei contenuti. Gli algoritmi dei social non si preoccupano minimamente di verificare la solidità delle notizie. Il loro unico scopo è creare una «Filter Bubble», una bolla di filtraggio che ti mostra solo ciò che ti piace. È come vivere in un mondo dove tutti ti danno ragione, anche se sostieni che Elvis sia vivo e stia gestendo un bar in Val Calanca.
Le conseguenze, dal punto di vista informativo, sono deleterie: i social media creano dipendenza psicologica, che si concretizza nel continuo scrolling di Facebook, Instagram o TikTok. In secondo luogo, favoriscono la polarizzazione delle opinioni e la mancanza di contraddittorio. E infine, ci immergono in una «echo chamber», una camera dell’eco, che ingigantisce le opinioni simili alle nostre, finendo col convincerci che la maggioranza delle persone la pensi esattamente come noi – anche se crediamo che le fogne di New York pullulino di coccodrilli e la top model che ci ha chiesto inaspettatamente l’amicizia online straveda per noi.
Scrivo queste righe mentre si susseguono notizie desolanti per il mondo dell’informazione svizzera, come l’annuncio del taglio di 900 posti nella SSR e delle centinaia di licenziamenti nei principali gruppi editoriali (TX Group, CH Media, Ringier). Senza contare l’imminente chiusura dell’edizione cartacea di «20 Minuti». La pubblicità è trasmigrata verso le piattaforme digitali (Google e Meta), prosciugando le casse dei giornali e delle TV. E così, grazie alla scelta deliberata di una beata ignoranza «social», i coccodrilli continueranno a proliferare sotto l’asfalto di New York e gli umani passeranno sempre più tempo chattando col profilo fake di modelle supersexy.