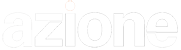Finalmente ieri sono riuscita a contarli: erano undici. Ancora una volta il mio tentativo di uscire dal posteggio di casa per immettermi sulla via cittadina si stava rivelando una missione impossibile. Ben undici automobilisti, con audaci manovre, avevano pensato di evitare l’ostacolo imprevisto che avrebbe potuto rallentare il loro procedere, peraltro già lento nel traffico del mattino. E non sia mai che si conceda qualcosa in più alla lentezza! In fiduciosa attesa li ho osservati, uno per uno, con cura, alla ricerca di un incontro di sguardi, ma dai finestrini affioravano solo figure opache, trasparenti e mute. Anch’io mi sentivo trasparente. Rinchiusi nei loro abitacoli, tutti a ritagliarsi immagini frantumate del mondo, in una solitudine surreale che sembrava voler soffocare ogni legame.
Anche in episodi minimi come questo capita a volte di provare sensazioni spiacevoli che fanno riflettere sul nostro modo di vivere e di convivere. Nel raccontare la quotidianità delle nostre relazioni, più volte abbiamo evocato il rischio di non riuscire più a percepire la presenza degli altri. E questo perché sempre più spesso siamo invitati ad essere presenti alla vita in modo performante, sollecitati ad esibirci nel suo grande spettacolo. Magari senza rendercene conto, nelle nostre relazioni assumiamo così una postura narcisistica e autoreferenziale. Il valore degli altri rischia allora di affievolirsi, o addirittura di sparire sullo sfondo dei nostri vissuti, consegnato solo alla sempre gradita attesa di un «mi piace». Quando l’altro non mi interpella più con il suo sguardo, la sua presenza si riverbera nel mio, solo per confermare il mio esserci.
C’è però un altro aspetto, più radicale, una condizione a priori del nostro attuale modo di abitare la vita che in modo sibillino si sta impossessando di molte forme della nostra convivenza. Dentro ciascuno di noi c’è un interlocutore privilegiato, una voce potente che precede la voce degli altri, seduce e avvolge le nostre giornate. È il mantra del cosiddetto tempo reale che, con tutta la sua irrealtà, con tutta la sua inconsistenza esistenziale, sta distruggendo l’esperienza umana del tempo, consegnandola al «qui adesso». Una perdita che viene a ferire i rapporti, a cominciare da quei minuscoli episodi di nervosismo nel traffico, fino a situazioni ben più significative e dolorose.
La chiamiamo lentezza, con un’accezione spesso negativa, questa esperienza umana del tempo. Eppure questa lentezza, che custodisce la purezza degli strati più profondi della nostra umanità, non è altro che il tempo autentico del nostro camminare nella vita. Per pensare, per sentire, per provare emozioni, per contemplare e per sognare, abbiamo bisogno di stare in questo tempo fecondo dell’umana lentezza, abbiamo bisogno di sostare nelle sue durate. A dispetto di un mondo che sembra voler correre verso la sua negazione, a dispetto del continuo essere sballottati sulla superficie di un presente che scandisce il nostro fare quotidiano, questo umana lentezza rimane il ritmo prezioso dell’anima che nutre e alimenta l’esperienza intima di sé.
Leggere una poesia, raccogliersi in una preghiera, stringersi in un abbraccio, commuoversi e condividere un dolore, come è accaduto a tutti noi durante la immane tragedia di inizio anno: esperienze come queste, nella letizia, così come nella nostalgia o nella più profonda sofferenza, sempre raccontano la forza e la bellezza di un vivere autentico: sono la verità di quel di più della vita che ci abita, nonostante tutto. Questi vissuti intimi e a volte segreti sono un invito a stare in ascolto dei tempi non misurabili dell’anima e a coltivare uno sguardo poetico sulla vita, in tutte le sue manifestazioni, in ascolto dei ritmi delle sue fioriture. Ce lo suggerisce anche Emily Dickinson la cui opera poetica è tutta attraversata proprio dalla lentezza, perché la vita per fiorire ha bisogno di tempo: ne ha bisogno per comprendere sé stessa e il mondo, per restare sempre in cammino, sempre in attesa, senza bisogno di alcun compimento. «Nessuna vita è sferica / tranne le più ristrette; / queste sono presto colme, / si svelano e hanno termine. / le grandi crescono lente, / dal ramo tardi pendono…».
Offrendoci l’immagine triste di un’umanità un po’ sperduta, la poetessa statunitense parlava, nell’Ottocento, di ristrette vite sferiche, incapaci di accogliere e coltivare le aperture della vita. Come non pensare, oggi, alle dolorose chiusure che incontriamo ogni giorno sulla nostra strada.