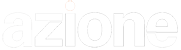Giuseppe Prezzolini fa parte della categoria degli intellettuali longevi che hanno lasciato in eredità una montagna di carta: libri, saggi, interviste, rubriche giornalistiche, diari, carteggi. Spentosi centenario a Lugano nel 1982, ha disposto che i suoi scritti venissero depositati nella Biblioteca cantonale. E lì sono rimasti, debitamente custoditi e classificati, a disposizione degli studiosi. Prezzolini ha attraversato una buona parte del Novecento da primattore del mondo delle lettere, come ricorda la mostra curata da Simone Bionda e Karin Stefanski negli spazi espositivi della Biblioteca (visitabile fino al 6 dicembre). Parallelamente Garzanti ha fatto uscire la biografia firmata da Emilio Gentile, un volume che non poteva non rispecchiare nella mole l’operosità del biografato: oltre 1200 pagine sotto il titolo L’avventura di un uomo moderno. Da tempo Gentile aveva in animo di occuparsi di Prezzolini, come figura-chiave dell’Italia giolittiana e del successivo ventennio fascista: un «anarchico conservatore» che non amava i metodi del regime ma ammirava Mussolini. E già questo sdoppiamento appare curioso e intrigante, riflesso di una vita ricca e movimentata, in ogni caso fuori del comune, dipanatasi tra Firenze, New York e negli ultimi anni a Lugano, in via Motta 36, dove ha composto, ormai mezzo cieco, un Ritratto di me stesso che Gentile riproduce nella forma originale, senza intervenire sull’ortografia.
Prezzolini è stata una personalità importante per la definizione della fisionomia cultural-linguistica e spirituale della Svizzera italiana. Le provocazioni che dal 1912 in poi rivolse ai ticinesi dalle colonne della sua rivista, «La Voce», innescarono un dibattito su quale fosse la vera «anima» del Cantone che ebbe vasta e perdurante eco. Scrisse il 18 luglio: «Il malessere del Ticino è il malessere del compagno spregiato, abbandonato, calpestato. Ultimo in casa, Cenerentola della Svizzera, meno ricco e forte dei tedeschi, meno ricco e meno colto dei francesi, soffre di una serie continua di impercettibili disdegni e punture da parte dei confederati. […] Non ha un’anima propria, perché non ha una coltura propria. Soffre proprio nella testa. Non si è sviluppato del tutto. Ha la vita economica, ha la vita sociale, ha la vita politica: gli manca la vita intellettuale. Non è un’anima completa. Non è rispettato, perché gli sentono che manca di anima». Parole forti, pronunciate da un letterato che in quel giro d’anni si era dato come compito di sondare gli umori di quelle province italiane di confine che ancora «gemevano» sotto il giogo austriaco, ovvero il Trentino e la Venezia Giulia. In tale contesto risultava naturale interrogarsi su quale fosse lo stato d’animo del Ticino e delle valli italofone grigionesi, quali fossero i loro veri sentimenti patriottici e la saldezza del loro senso di appartenenza alla Confederazione.
La questione fu subito ripresa da Francesco Chiesa, lo scrittore che già nel 1908 aveva redatto un «manifesto» a difesa dell’italianità, nel quadro di una possibile costituzione di una sezione svizzera della società Dante Alighieri. Fu così deciso, in accordo con Prezzolini, di dedicare all’argomento un numero speciale della «Voce», che uscì l’8 dicembre del 1913, con contributi, oltre che di Chiesa, dello storico Emilio Bontà (caratteristiche del Cantone ed emigrazione), del narratore e critico Augusto Ugo Tarabori (condizione culturale) e del pastore protestante di origine romanda Edouard Platzhoff (Grigioni italiani). La discussione si inscriveva in un contesto che, agli occhi del piccolo mondo intellettuale ticinese, si era andato degradando per effetto di un insieme di fattori, interni ed esterni: la sordità di Berna nei confronti delle rivendicazioni delle minoranze, la crescente penetrazione di «elementi alloglotti» (tedescofoni) nel tessuto urbano dei principali centri lacuali, l’alterazione dei caratteri genuini, linguistici e religiosi, della compagine latina. L’Italia era naturalmente interessata al disagio del Cantone, nella speranza – presto rivelatasi illusoria – che un giorno potesse «emanciparsi» dai vecchi signori confederati per ricongiungersi alla «gran madre» italica.
Ritornare oggi su quelle pagine vuol dire riprendere il filo di un discorso che in fondo non si è mai interrotto, nemmeno durante il fascismo e la chiusura delle frontiere: una sollecitazione che ci riporta a riflettere sulla nostra identità di svizzeri italiani, in un continuo confronto e scambio con i nostri vicini del nord e del sud.