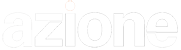Profittando dell’attenzione internazionale sul genocidio nella Striscia, il Governo Netanyahu ha accelerato la costruzione di nuovi insediamenti nelle terre che chiama «Giudea e Samaria». Si parla di annessione formale: escalation in vista
La guerra su sette fronti scatenata da Israele in risposta al massacro del 7 ottobre è destinata a durare a tempo indeterminato. Di più: è stata costruita per non avere una fine, ma per ristabilire la deterrenza dello Stato ebraico nel suo vicinato. Il fragile cessate-il-fuoco sul fronte di Gaza, più volte interrotto, non sembra peraltro capace di andare oltre lo scambio di ostaggi. Il famoso piano Trump che dovrebbe portare per gradi all’affermazione di un protettorato internazionale sulla Striscia, a guida trumpiana, è in stallo.
Per capire questa situazione conviene tornare all’origine. Ovvero alla scelta dello Stato ebraico, e in particolare del suo leader Bibi Netanyahu, di vendicarsi del sanguinoso pogrom di Hamas. Una vendetta non è una strategia. È il tentativo di contenere la pressione dell’opinione pubblica israeliana, traumatizzata come mai dalla sconfitta e dalla pur breve invasione di territorio proprio da parte delle milizie islamiste. Allo stesso tempo, Israele intende iniziare a rompere l’assedio iraniano via propri clienti nella regione e nei territori occupati, fino a mettere in questione il ruolo di Teheran come potenza regionale. Quel che non tanto il massacro di Hamas quanto la risposta di Gerusalemme ha tragicamente cambiato, e che continuerà a cambiare tra una tregua e l’altra, è il rapporto di forza tra i contendenti.
Israele molla Gaza
Questa guerra di Gaza termina il presunto status quo fissato nel 2005 dal Governo Sharon, d’intesa con Bush junior: Israele molla Gaza, contando sul fatto che i palestinesi vi si sarebbero sbranati per controllarla. Scommessa vinta. Prima via liquidazione di Fatah e Anp da parte di Hamas nel 2006, oggi nella caccia dei militanti islamisti ai clan e alle milizie arabe affittate da Israele, in crudo svolgimento. La mossa di Sharon puntava sulla progressiva penetrazione dei coloni in Cisgiordania, dove l’Anp di Abu Mazen si era autoridotta a mini-Quisling, abile soprattutto nel taglieggiare i compatrioti e intascare gli aiuti israeliani e internazionali. Fantasma utile a Israele perché teneva in piedi la favola dei due Stati, che tutt’ora assicura l’esistenza di un unico Stato, il proprio, sulla base di rapporti di forza totalmente asimmetrici. La questione palestinese era così messa in naftalina. Israele trattava con sé stesso, per modulare tempi e modi dell’annessione formale della Cisgiordania. Da Rabin a Netanyahu tutti i Governi israeliani avevano scommesso su Hamas per spaccare un fronte palestinese già sufficientemente diviso. A costi abbastanza limitati, in collaborazione con il Qatar (soldi) ed Egitto (esercito e intelligence), le porte di Gaza erano subaffittate al movimento islamista, classificato terrorista eppure titolare di puntuali versamenti mensili via corrieri con valigetta Doha-Tel Aviv-Gaza. Oggi la partita di Gaza è sempre più legata a quella in Cisgiordania.
Profittando dell’attenzione internazionale sul genocidio nella Striscia, il Governo Netanyahu ha accelerato la costruzione di nuovi insediamenti in quelle terre che Israele chiama biblicamente Giudea e Samaria. La decisione della Knesset di avviare la discussione sull’annessione formale di questi territori occupati sembra anticipare un incendio di proporzioni geopoliticamente maggiori rispetto a quello di Gaza. Se Gerusalemme dovesse affermare la propria sovranità su territori che in realtà già controlla, ma che per il diritto internazionale non le appartengono, per i Paesi arabi diventerebbe impossibile riprendere la strada che adesso surrettiziamente riesplorano con la mente. Ovvero recuperare ed espandere gli accordi di Abramo con Israele, basati sullo scambio di tecnologie e armi israeliane con energie e asset finanziari arabi. Tutte le iniziative della Casa Bianca hanno sempre mirato a ripristinare questo sogno, poggiato peraltro su interessi molto concreti. E sulla generale indifferenza dei regimi arabi per la causa palestinese. Un fatto che rende ancora più evidente l’asimmetria fra i contendenti. Da una parte una potenza economica, tecnologica e militare di grande spessore, appoggiata dagli Stati Uniti, dall’altra un popolo diviso e abbandonato da coloro che negli anni successivi alla fondazione dello Stato ebraico si erano battuti, almeno nominalmente, per restituire ai palestinesi le terre e le case perdute nella guerra del 1948.
Palestinesi divisi
Peggio, i palestinesi hanno confermato in questa guerra di essere tutt’altro che uniti. Consideriamo solo l’atteggiamento dei palestinesi di Israele, cittadini di serie B o anche solo ospiti (Gerusalemme Est) dello Stato ebraico, di fronte al genocidio dei presunti fratelli della Striscia: non hanno mosso un dito. E consideriamo anche il grado di frattura che all’interno di quel mondo separa storicamente i clan, le famiglie e altri aggruppamenti informali. Con ciò si rende evidente che in ogni caso uno Stato nazionale palestinese non sarebbe in ogni caso possibile per carenza di Nazione. Eppure continuiamo a parlarne come se fosse un’opzione plausibile. Un esempio fra molti di come il principio di realtà sia oggi espunto dalle relazioni internazionali. Scontato che chiudere in tempi ragionevoli i sette fronti aperti non è possibile, sarà decisivo per Trump, che tanto ha scommesso sulla sua «pace» in Medio Oriente, fornire finalmente un’idea dettagliata di come gestire un’emergenza che altrimenti rischia di sfuggirgli di mano. Con conseguenze non solamente nella regione, ma nel mondo.