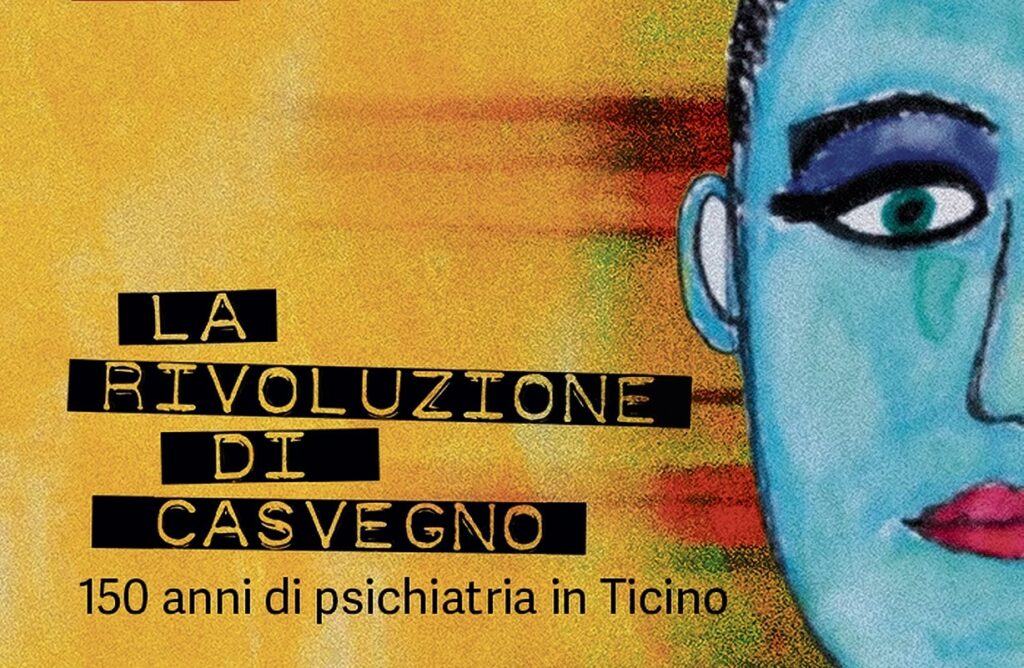Un podcast in sette puntate del regista Olmo Cerri ripercorre la storia della psichiatria nel nostro cantone
Stamani, mentre ero pigramente immobile a letto, ha bussato alla porta della mia stanza il Messeri, un ex malato di mente, qui ricoverato, che mi copiava a macchina gli scritti. Già prima di vederlo l’ho riconosciuto dalla voce. Poiché forse se l’aspettava, gli ho regalato un pacchetto di sigarette, e mi ha risposto con una gentilezza che i sani non hanno: «Non le fumerò, le terrò per ricordo».
L’«ex malato di mente» di cui sopra non esce dalla memoria di qualcuno transitato in una veste o un’altra da Casvegno, Mendrisio, bensì dalla penna di Mario Tobino nel suo Le libere donne di Magliano (1953). Lo psichiatra, scrittore e poeta italiano (1910-1991), autore di Il perduto amore e Gli ultimi giorni di Magliano ebbe un rapporto controverso con la legge Franco Basaglia, e cercò di opporsi alla chiusura dei manicomi. Ma se lo abbiamo citato in questa sede, per parlare di un podcast su Casvegno, è per i tratti delicati con cui Tobino illustrava i suoi personaggi (che erano poi i suoi pazienti), per la cura con cui sceglieva le parole per descriverli, per la delicatezza e l’affetto che metteva in campo di fronte alla malattia mentale. Ecco, molte volte abbiamo avuto queste sensazioni anche nel corso dell’ascolto del più recente lavoro di Olmo Cerri, sette puntate dedicate alla Rivoluzione di Casvegno, un podcast prodotto dalla RSI e sostenuto dall’Associazione REC, per raccontare la storia dell’OSC, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, già ONC Organizzazione neuropsichiatrica cantonale, e prima ancora, manicomio.
Proprio dal manicomio parte la ricerca durata sei mesi di Cerri, dall’immensa donazione di terreno fatta da Agostino Maspoli al Canton Ticino nel 1870, affinché vi edificasse un luogo in cui curare la malattia mentale, che aveva colpito anche sua moglie, e che, allora, veniva tutt’al più curata all’estero, per arrivare ai giorni nostri, con sfide inattese che stanno mettendo a dura prova l’istituzione cantonale.
Olmo Cerri, che prima di divenire cineasta ha assolto una formazione di educatore sociale ritorna sui luoghi del suo stage per un’indagine che cerchi di ripercorrere in sette tappe la storia unica di questo ospedale, soffermandosi anche sui punti oscuri che a volte fanno della psichiatria e di tutto ciò che le ruota intorno materia di controversie. Nel corso dei suoi numerosi incontri, e attraverso le testimonianze di infermiere, assistenti sociali, medici, ma anche documenti e vecchi articoli, si offre il ritratto di un luogo che ha subito ma anche dato vita a numerose trasformazioni, in modo sempre più orientato al benessere e alla dignità del paziente, o residente.
Per molti anni l’istituto di cura di Mendrisio fu contraddistinto da una gerarchizzazione estrema delle funzioni: il ruolo di chi ci lavorava e la sua importanza, spiegano bene lo psichiatra Graziano Martignoni e il già animatore del servizio di socioterapia Manolo Lacalamita, era dichiarato dal colore della divisa e dal numero di chiavi di cui un medico era in possesso. Più era grande il numero di chiavi che aprivano porte, maggiore era il potere. Varie forme di contenzione non erano estranee alla pratica di cura, così come negli anni si è ricorsi a misure come la lobotomia.
Il punto di svolta a Mendrisio (la politica psichiatrica in Svizzera non è condivisa e ogni cantone ha diritto a determinate scelte terapeutiche) arriva grazie a un doppio input accolto dagli allora psichiatri Elio Gobbi e Giuseppe Bosia: dall’Italia la spinta all’apertura fu di Franco Basaglia, mentre dalla Francia giungeva il vento nuovo della psicoterapia istituzionale portato da Ettore Pellandini, che aveva lavorato per molti anni nella clinica francese la Borde fondata da Jean Oury. L’avvocato Marco Borghi fece sua la causa dell’innovazione con il sostegno di un gruppo di psichiatri, sotto l’allora Consigliere di Stato, Benito Bernasconi, e ne scaturirono un’istituzione con un’umanità nuova e una legge sociopsichiatrica (LASP).
Come raccolto da Cerri nelle numerose testimonianze, la vita all’interno dell’istituto cambiò, ai pazienti venne gradualmente accordata un’autodeterminazione sempre maggiore, grazie anche a una piazza di scambio importante e unica nel suo genere, attiva ancora oggi. Esattamente 51 anni or sono nasceva infatti l’Associazione Club 74, luogo aggregativo, di scambio di opinioni, sede di bar e di atelier, con un approccio terapeutico apertamente improntato sulla «suddivisione del potere tra pazienti e operatori».
La storia di Casvegno narrata nel podcast, non si riduce unicamente a un elenco cronologico di fatti che hanno portato a un’apertura tale da permettere di guardare con serenità anche a zone d’ombra appartenenti al passato (nel corso dell’ascolto si percepisce a più riprese quanto in fondo sia giovane la disciplina della psichiatria e quanto sia dovuta essere spesso sperimentale), ma offre anche una lettura del complesso contesto sociale in cui ci troviamo. La malattia psichiatrica, per la quale si è fatto molto, riuscendo in alcuni casi anche a portarla sul territorio, grazie al sostegno offerto dai centri diurni, non è oggi più prerogativa esclusiva dell’OSC. Come in molte altre realtà, la recrudescenza del consumo di sostanze stupefacenti si riflette anche sull’ospedale: nel cantone mancano infatti centri di disintossicazione. A questa utenza, che entra in collisione con i pazienti psichiatrici, si è aggiunta anche una nuova tipologia di malato, risultato di un’era come la nostra, spesso improntata alla solitudine. Senza contare le decine di adolescenti, ultima delle sfide in ordine di tempo, da anni temporaneamente parcheggiati a Mendrisio, in attesa della creazione di strutture più adeguate.
Come sottolineano alcuni degli intervistati, e come rilevato dallo stesso regista del podcast, la lotta per i diritti (dei pazienti, alla libertà, alla sicurezza), non può mai dirsi conclusa, soprattutto in un mondo come quello attuale, incline a erigere muri e costruire steccati. Per garantire una buona cura sono necessarie risorse, occorre credere al fatto che una società equa passi anche attraverso chi non sta bene, così come fa indefessamente chi, giorno dopo giorno lavora a contatto con i residenti dell’Ospedale, spesso correndo dei rischi, altre volte facendosi forte di un’empatia che va ben oltre la mera professione.
Un lavoro vivace, capace di concedere momenti intensi alla riflessione, in cui il caleidoscopio di personaggi intervistati concorre a tratteggiare un universo sconosciuto, ma che non merita di esserlo, poiché a pochi passi da molti di noi, e soprattutto perché aperto. Come suggeriscono alcune descrizioni, l’OSC val bene una visita, per un tuffo in un tempo lontano, ma anche in una sorta di omaggio a chi, a modo suo e con i suoi mezzi, ha fatto un pezzo di storia del nostro cantone.