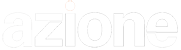Incontri: Pedro Juan Gutierréz, tra i massimi scrittori cubani, racconta come la vita dell’isola caraibica abbia cambiato la sua scrittura
Raggiungo Pedro Juan Gutierréz nella casa del figlio nel quartiere residenziale del Vedado. Ci accomodiamo nell’androne, uno di fronte all’altro, mentre il comune amico Davide Barilli, parmense, il più cubano degli scrittori italiani, traduce la nostra conversazione. È un uomo alto, calvo e magro, l’aria mite e ascetica di chi da qualche anno fa yoga, meditazione e pratica le idee buddiste.
Per capire veramente la capitale più profonda, quella vitalistica e disperata, bisogna necessariamente leggere Il re dell’Avana (e/o), ambientato nel quartiere più popolare della città, un barrio abitato da una umanità stremata ma estremamente sensuale, tra i riti della santeria, la religione afro-cubana, e la precarietà esistenziale di vite segnate da miseria ed emarginazione. Il romanzo, scritto con uno stile che è stato definito «realismo sporco», nato da una filiazione del minimalismo americano, è la disperata storia d’amore di due giovani cubani che vivono per strada nel sudiciume e nel degrado, Rey, ragazzo orfano e senza famiglia che vive di piccoli furti, per sopravvivere s’inventa qualsiasi cosa, così come per aumentare la sua potenza sessuale e vivere le sue avventure erotiche si fa impiantare due palline d’acciaio nella punta del pene, e Magda, che per sbarcare il lunario arriva a prostituirsi con vecchi derelitti.
Quello che oggi è considerato uno dei massimi scrittori cubani, tradotto in molti Paesi, è stato venditore di gelati, soldato, istruttore di nuoto, tecnico delle costruzioni, professore di disegno, autore di documentari, e per tanti anni giornalista e speaker radio-televisivo. Tra gli altri suoi libri tradotti in Italia, sempre dalle edizioni e/o, Animal tropical, Malinconia dei leoni, Carne di cane, Il nostro GG all’Avana e Il nido del serpente.
I primi racconti de La trilogia sporca dell’Avana (Edizioni e/o) sono anche dei reportage, dei racconti dal vero da cronista, quasi delle inchieste sul campo, che poi è stato per quasi trent’anni il suo mestiere. Ha definito il suo stile diretto, in prima persona, autobiografico, «senza troppe masturbazioni mentali». Come si intrecciano scrittura letteraria e giornalismo?
Da ragazzo andavo nella biblioteca pubblica di Matanzas, e quando ho letto Colazione da Tiffany di Truman Capote ho pensato che volessi scrivere come lui, ma leggevo anche Alejo Carpentier e Lezama Lima, e non mi piaceva Garcia Marquez, perché è troppo barocco, lezioso. Quando mi sono trasferito a La Havana lavoravo come giornalista in un’agenzia di stampa governativa, lì ho imparato veramente a scrivere con pochi aggettivi in uno stile secco, essenziale, ma la letteratura allora la tenevo nascosta. Poi quando nel 1994 ho scritto il primo racconto de La trilogia sporca dell’Avana ho capito che tutto quello che c’era stato prima non valeva niente, avrei voluto bruciare tutto come Kafka. Mi sono trovato immerso in un mondo particolare, quello del Centro Avana, un mondo a parte rispetto al resto della città, dove la gente ha una propria religiosità, la santeria, e le persone sono molto tattili, corporali, e pur essendo un giornalista della media borghesia ho assorbito questo tipo di vita, mi è entrata dentro vivendo in mezzo a loro, ascoltando le loro storie, in modo del tutto naturale.
Le loro storie e l’anima «tropical» sono molto crude, brutali, ha scritto che addirittura «alcune erano così forti che ho dovuto ammorbidirle».
Quando sono venuti a intervistarmi dall’Università di Chicago ho detto che in realtà sono un antropologo. I nonni e i bisnonni delle persone che vivono in questo quartiere erano tutti africani schiavi, lavoratori della canna da zucchero, con uno spirito molto diverso da quello dell’Avana che conoscevo, uno spirito caliente, tutti chiusi nel loro quartiere, nel loro mondo, disinteressati alla politica, a quello che succedeva fuori. In Inghilterra e negli Stati Uniti non vogliono tradurre Il re dell’Avana perché dicono che è troppo forte, troppo duro. La loro religione li unisce molto perché a differenza di quella cattolica che ha i suoi templi, le chiese, lì si riuniscono nelle case per fare i cerimoniali. È un mondo forte e autosufficiente, un po’ picaro, maledetto. È gente molto dura, hanno molta energia e allegria, non si buttano giù, per questo mi hanno sempre affascinato molto, non si lasciano sopraffare dalla povertà.
I personaggi de Il re dell’Avana vivono l’alcol e l’estasi sessuale come gli unici piaceri in vite spesso estreme, disperate, un modo di provare piacere in un ambiente sociale segnato dalla povertà e dal degrado. Dice del protagonista, «c’è chi vive alla giornata, Rey viveva al minuto».
Io credo di utilizzare il sesso sempre come un elemento drammatico, e poi noi siamo cubani, per noi il sesso è la cosa più naturale di tutte, la nostra cultura profonda è fatta principalmente di erotismo e musica. Comunque, la vita quotidiana di quelle persone funzionava così, questo intreccio tra alcol e sesso era fortissimo, ma anche io ero così in quel periodo, mi ero da poco separato da mia moglie, avevo perso il lavoro e vivevo da solo in Centro Havana, la mia vita era fatta di sesso sfrenato e alcol sfrenato.
Alla mia crisi personale nel 1991 si aggiunse quella economica terribile di Cuba dopo la caduta dell’Unione Sovietica, che ha impoverito drammaticamente il Paese; quindi, scrivere è stato anche un modo per salvarsi, per buttar fuori tutta la mia furia, la rabbia, l’amarezza che avevo dentro.
Per questo motivo l’hanno ribattezzata il Bukowski cubano?
Non lo so, mi pare più un’invenzione giornalistica. Tra l’altro non amo Bukowski, lo trovo noioso, ripetitivo, a differenza di Raymond Carver, che è anche un poeta, uno scrittore che apprezzo moltissimo e che ha nutrito la mia letteratura, così come amo Grace Paley.
Nella sua prosa che è sempre molto carnale, corporale e ruvida, c’è sempre però una miscela di drammatico e comico.
Non vedo mai la vita come una tragedia ma come una grande commedia; quindi, c’è sempre anche un forte senso dell’umorismo. Invece il machismo di Pedro Juan personaggio, il mio alter ego de La trilogia sporca dell’Avana, questa maschera, i lettori lo riversavano anche su di me come persona, invece, era tutta una messa in scena, mi sono divertito ad esasperarne certi aspetti.
Sono tre libri autobiografici, mentre Rey, il protagonista de Il re dell’Avana nasce da un personaggio realmente esistito, e anche Maddalena, Magda, la sua ragazza, vendeva davvero coni di manì davanti all’ospedale Hermanos Ameijeiras. La storia che si fa impiantare due palline di acciaio nella punta del pene però l’ho sentita quando sono andato a fare un reportage per la rivista «Bohemia» nel carcere minorile Combinado dell’est, parlando con un infermiere.
Pensavo di scrivere un racconto di sei o sette pagine, poi è diventato un romanzo. Non volevo più parlare di Centro Havana e invece questa storia mi ha talmente coinvolto che in due mesi ho scritto il libro lavorando giorno e notte, bevendo come un pazzo il rum della pipa, un rummaccio pessimo, quasi alcol puro, e girando di notte con le prostitute, facendo l’amore, bevendo e scrivendo.
Quale sarà il suo prossimo libro?
A giugno esce un mio libro di testi autobiografici in Spagna, ma uscirà presto anche in Italia, si intitola Meccanica popolare, dove racconto la mia formazione, gli anni dell’adolescenza. Sono momenti, frammenti, capsule che si intrecciano uno nell’altro. Il titolo è quello di una rivista americana tradotta in spagnolo in Messico, una edizione per l’America Latina che arrivava anche a Cuba e che leggevo da ragazzino. L’ho ritrovata un paio di anni fa in una libreria dell’usato, e sfogliando quei fascicoli mi ha fatto ripartire la memoria, i ricordi, è un libro ambientato a Matanzas, Pinar del Rio dove sono vissuto, una sorta di raccolta dei racconti di famiglia, senza parlare di politica, dei fatti storici importanti che accadevano. Sono storie di vita, quella di mio padre, di mio zio, quelle della nostra famiglia, insomma.