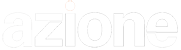Dove nasce l’altruismo ◆ Le neuroscienze rivelano come il «cervello sociale» ci renda naturalmente inclini all’empatia e al dono
Viviamo in una società occidentale individualista, ma pratichiamo comunque gesti quotidiani di altruismo, dalla cortesia al volontariato. Lo conferma uno studio dello psicologo sociale Stefan Pfattheicher. Fare del bene agli altri significa anche fare del bene a sé stessi, come mostrano diverse ricerche. Martin L. Hoffman, nel 1978, descrive l’altruismo come un comportamento che «favorisce gli altri senza considerare il proprio interesse», legandolo ai meccanismi empatici sviluppati fin dall’infanzia. Anche Nancy Eisenberg e Paul Miller evidenziano che tali gesti avvengono senza aspettarsi ricompense. Altri studiosi, come il sociologo russo Andrey V. Bykov, considerano l’altruismo una norma morale che spinge a mettere in secondo piano i vantaggi individuali per sostenere la collettività. Le ricerche internazionali mostrano però che le modalità dell’altruismo riflettono la cultura di appartenenza: negli Stati asiatici la generosità si estende a estranei anche lontani, mentre in Occidente si concentra sui legami più stretti. Differenze tra nazioni rivelano come storia, norme e fiducia modellino il nostro modo di aiutare: la maggiore propensione italiana al dono rispetto alla Danimarca, la pro-socialità dei Paesi nordici o la sfiducia ereditata in molte aree post-sovietiche. In Svizzera emerge una cultura sorprendentemente collettivista, basata su norme implicite e una forte pressione al conformismo: silenzio, sobrietà e armonia diventano codici sociali che regolano le interazioni e influenzano anche l’espressione dell’altruismo.
Le neuroscienze confermano questo quadro, mostrando come il cervello sociale si plasmi in risposta alle norme e ai valori del contesto in cui cresce. Ne parliamo con la neuroscienziata Rosalba Morese, esperta in psicologia e neuroscienze sociale dell’USI, alla quale abbiamo chiesto di spiegarci perché aiutiamo gli altri e per quale motivo a volte, quasi senza pensarci, siamo spinti a fare un gesto gentile, sostenere una causa, donare tempo o denaro. «La nostra capacità di cooperare non è solo un fatto culturale o morale, ma è iscritta e intrinseca alla nostra biologia, ai nostri circuiti cerebrali. Il nostro cervello, infatti, non si è evoluto solo per percepire il mondo o risolvere problemi, ma anche, e forse soprattutto, per vivere insieme agli altri». È il cosiddetto «cervello sociale», e la nostra interlocutrice ha approfondito questo tema in un editoriale con la collega Sara Palermo dell’Università di Torino, dove lo definisce come «un insieme di reti e funzioni che ci permettono di elaborare emozioni, intuire intenzioni e desideri, e comprendere punti di vista diversi dal nostro». Spiega che senza questi meccanismi non esisterebbero amicizie, reti sociali, comunità, né tantomeno altruismo o filantropia. «La teoria della mente, l’empatia e la cognizione sociale sono i tre pilastri di questo sistema», sottolinea Morese che ricorda come, grazie ad essi, riusciamo non solo a capire che un’altra persona sta soffrendo, ma anche a sentirci spinti ad aiutarla. L’altruismo nasce proprio da questo: «Dalla capacità di rappresentare la mente delle altre persone, sentire le loro emozioni e provare un senso di responsabilità verso il loro benessere». La decisione di donare non è un processo singolo: «È una serie di passaggi che coinvolgono diverse parti specializzate del nostro cervello sociale, dal reclutamento delle aree dell’empatia che consentono di simulare e risuonare le emozioni e situazioni, passando alla comprensione ed elaborazione di aspetti quali credibilità, affidabilità e conseguenze della nostra donazione, per finalizzarsi con l’integrazione di tutte le informazioni a disposizione e poter poi decidere se donare o meno».
In questo quadro, la filantropia è la forma più organizzata di altruismo: «Una versione strutturata e stabile di quel movimento interiore che ci porta a prenderci cura degli altri». Prospettiva neuroscientifica che ha un ruolo ancora più centrale se guardiamo all’adolescenza, fase della vita in cui il cervello sociale è in piena trasformazione: «Gli adolescenti sono particolarmente sensibili alle dinamiche del gruppo, alle emozioni e al giudizio dei pari. Non è solo una dimensione psicologica: è il risultato di un processo neurofisiologico che costruisce le basi neurali sottostanti alla capacità di leggere gli stati mentali altrui e di agire in modo prosociale». A questo proposito, Morese aggiunge: «Mette in luce come il donare sia un processo profondamente radicato nella neurobiologia del nostro cervello sociale, regolato da specifiche aree cerebrali; capire questi meccanismi significa comprendere meglio come nasce la disponibilità ad aiutare».
Oggi sappiamo che donare è un comportamento che migliora il benessere sia di chi riceve che di chi dona, «perché recluta i circuiti cerebrali dell’appartenenza al gruppo creando gratificazione e piacere: l’altruismo attiva circuiti di ricompensa anche quando il donatore rimane anonimo; l’empatia è necessaria ma non sufficiente. Per contro, sappiamo che la componente della fiducia che percepiamo può modulare il comportamento altruistico». Ma la forza del cervello sociale non si limita alle relazioni personali: «Essa riguarda anche le organizzazioni e i sistemi economici. Ad esempio, analizzato attraverso la lente delle neuroscienze il concetto di capitalismo consapevole suggerisce che le aziende che incorporano empatia, responsabilità e valori etici funzionano meglio non solo a livello sociale, ma anche produttivo. La nostra natura cooperativa, evolutivamente vantaggiosa, può quindi essere un motore per imprese più umane, dove il profitto convive con lo scopo e l’impatto sociale». Non sorprende che molte ricerche mostrino come i comportamenti altruistici aumentino il benessere sia delle persone sia delle organizzazioni.
L’altruismo, però, non si manifesta allo stesso modo in tutte le culture: gli studi interculturali distinguono tra società individualiste, più orientate al sé, e società collettiviste, in cui la cooperazione è un valore centrale. In questo confronto, la neuroscienziata evidenzia due «forme» di altruismo: «Una più impura, spinta anche dal desiderio di sentirsi bene, e una più pura, focalizzata sul beneficio altrui». Differenze che modellano il modo di donare e influenzano la relazione tra altruismo e felicità: «Nelle culture collettiviste, per esempio, aiutare è parte dell’identità sociale». Ciò conferma che, anche nelle imprese, cultura e legami sociali hanno un ruolo decisivo: «Il rapporto tra filantropia aziendale e performance finanziaria, molto studiato, dipende non solo da strategie economiche ma anche dalle caratteristiche psicologiche dei dirigenti». Un fattore rilevante è l’attaccamento al luogo d’origine: «Chi conserva un forte legame con la propria comunità tende a sostenere iniziative benefiche locali, rafforzando la legittimità sociale dell’azienda». E questo è un chiaro esempio di come anche le scelte economiche affondino le radici nella nostra natura relazionale.
In sintesi, conclude Morese: «Il cervello sociale è il terreno comune che collega empatia, altruismo e filantropia: comportamenti che non sono eccezioni alla regola, ma una parte fondamentale di ciò che significa essere umani». Allora, comprenderne le basi neuroscientifiche ci aiuta non solo a spiegare perché doniamo, ma anche a immaginare società e organizzazioni più consapevoli, cooperative e orientate al benessere individuale e collettivo.