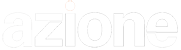L’ex reporter ticinese Filippo Rossi ricorda l’ottobre 2017 quando ha visto da vicino la brutalità del regime di Maduro
Mentre in Venezuela si aprono le celle e decine di detenuti tornano in libertà (leggi articolo in basso), riaffiora la storia di un ticinese che, qualche anno fa, di quelle prigioni ha avuto solo un assaggio, ma gli è bastato per scoprire quanto fosse amaro. Stiamo parlando di Filippo Rossi, per lunghi anni reporter in aree instabili del mondo e runner estremo (ovvero chi partecipa a corse infinite in condizioni climatiche al limite, quali deserti e giungle tropicali). Lo abbiamo incontrato a Lugano, dove vive un’esistenza più tranquilla, giocata sul valore degli affetti e un lavoro che non lo costringe a prenotare un volo ogni volta che scatta un’emergenza. Da qui torna con la memoria all’ottobre del 2017 quando, insieme al collega italiano Roberto di Matteo, è partito alla volta di Caracas, un viaggio con un epilogo imprevisto che li ha lasciati con il fiato corto.
Non c’era niente: alimenti, farmaci e servizi essenziali
«L’intenzione – ci dice – era quella di raccontare, senza filtri, cosa stava succedendo in una Nazione alla deriva, devastata dalla crisi: iperinflazione esplosa, Pil crollato, prezzi del petrolio dimezzati. Non c’era niente: alimenti, farmaci e servizi essenziali. La criminalità imperversava. La gente stava male e lo esprimeva in piazza». Ma le proteste di massa sono state represse con estrema violenza, mentre l’Assemblea Costituente voluta da Maduro aveva aperto una frattura istituzionale profonda. «Si trattava di una tipica dittatura». Era l’anno in cui le crisi economica, sociale e politica si saldavano in un’unica emergenza nazionale, alimentando un esodo di massa dal Venezuela.
«La prima settimana – continua il nostro interlocutore – l’avremmo passata col giornalista Jesús Medina di “DolarToday”, un portale web di opposizione noto principalmente per il monitoraggio del tasso di cambio del dollaro nel mercato nero in Venezuela. La seconda l’avremmo trascorsa invece con un “fixer” (aiuto locale) filogovernativo che ci avrebbe portato a vedere il volto chavista e madurista del Paese. Ne abbiamo raccolte di storie in pochi giorni! Al Parque central di Caracas, ad esempio, abbiamo intervistato il capo dei Tupamaros, un collettivo armato allineato al Governo noto per il controllo del territorio nei quartieri popolari della città. Ci siamo pure spinti nella Cota 905, il quartiere più pericoloso della capitale: le strade erano presidiate da gruppi dall’aria dura, sguardi che ti pesano addosso, e armi in vista come fossero parte dell’arredo urbano. Ma è andata bene».
Una cittadella criminale
I problemi sono esplosi quando Rossi e di Matteo – con l’aiuto di Medina che aveva i contatti giusti – hanno tentato di introdursi nella prigione più stramba e violenta del Venezuela: Tocorón nello Stato di Aragua. «Volevamo occuparci di quel carcere perché era un caso interessante. Si trattava di una struttura di fatto gestita da una banda criminale guidata da Niño Guerrero, con detenuti liberi di muoversi e infrastrutture costruite da loro stessi: piscine e jacuzzi, una discoteca, un casinò, ristoranti, negozi, perfino un mini-zoo. All’interno circolavano prostitute, droga e armi à gogo». Un penitenziario trasformato in una cittadella criminale fuori controllo, insomma. Il via libera «sia dall’interno della struttura, sia dalle autorità penitenziarie» è arrivato il 5 ottobre 2017. Il giorno dopo i tre giornalisti si sono presentati davanti al cancello di Tocorón. Ma le cose sono precipitate: l’incontro «teso» con il direttore della struttura accompagnato dal viceministro delle carceri venezuelane Vilmer Apostol e dal capitano della guardia bolivariana, poi le manette. L’accusa? Avere introdotto attrezzature audiovisive senza autorizzazione. «Ma – per Rossi – si trattava di una trappola. Ci hanno accusato di voler infangare il Venezuela. Diosdado Cabello, allora potentissimo vicepresidente del partito di Governo venezuelano (PSUV), ha twittato che avremmo dovuto essere fucilati».
La notizia rimbalza
In ogni caso la notizia, grazie alla denuncia del sindacato dei giornalisti venezuelano, rimbalza subito sui media di tutto il mondo. Grazie all’intervento del Ministero degli esteri italiano e del Dipartimento federale degli affari esteri, i tre – dopo due notti passate in carcere – vengono rilasciati. Al rientro di Rossi in Svizzera esplodono le polemiche: il giornalista accusa l’ambasciata elvetica di scarsa assistenza e Marco Chiesa presenta un’interrogazione parlamentare. Ma lasciamo da parte quelle vicende per passare a ciò che Rossi ha visto in carcere laggiù: «Ci hanno portati al Tocoróncito, un edificio che sorge su una collinetta proprio davanti a Tocorón. Gli agenti sono stati rispettosi». Una telefonata a testa e poi in cella. «È stato terribile: spazi di pochi metri in cui erano stipate 12-13 persone in attesa di giudizio, con gente che dormiva ovunque, per terra. A noi, perché stranieri e giornalisti, hanno concesso un privilegio raro: una cella per tre persone. In un angolo c’era un muretto con un buco per i bisogni, coperto da una bottiglia di plastica per attenuare gli odori; accanto un tubo usato come rubinetto, con un secchiello sotto. Un materasso lurido su chi abbiamo dormito in tre. Muri scrostati, ruggine dappertutto, di notte c’erano i ratti. Ci davano delle pitas in pasta di mais con dentro un po’ di pollo, qualità pessima ma almeno abbiamo mangiato. «La cosa più brutta: non sapere se e quando quell’incubo sarebbe finito».
Mentre cresceva l’ansia, dalle celle circostanti, quando non passavano le guardie, arrivavano bigliettini: «Detenuti e detenute che ci raccontavano la loro storia. Molti di loro erano stati accusati di rubare materiale strategico di Stato, come il rame. Qualcuno diceva che era stato fregato: gli avevano messo il metallo addosso…. Ogni tanto arrivavano bottiglie d’acqua ma anche commenti volgari e inquietanti». I tre reporter, alla fine, se la sono cavata: come detto dopo 48 ore sono stati giudicati e rimessi in libertà. Degli altri, invece, resta il dubbio: se abbiano avuto la stessa fortuna.