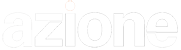La quotidianità del ricercatore italiano Marco Buttu alla stazione di ricerca Concordia al Polo Sud
«Adrenalina? Certo che ne ho provata. Durante, ma anche prima e dopo ognuna delle tre spedizioni. A fiotti, e con sentimenti ogni volta diversi fra loro». Basta questo incipit di Marco Buttu, protagonista dell’incontro odierno, per avere un posto di diritto nella rubrica Adrenalina.
Benché non pratichi il classico sport estremo. Marco Buttu è «semplicemente» un ingegnere elettronico, poi specializzatosi nella ricerca e nella manutenzione dei telescopi. Perché allora parlare di lui? Più che il «cosa» il 47enne sardo (di Gavoi) faccia, a rendere adrenalinica la sua storia, sono il «come» e soprattutto il «dove» lo fa. Iniziamo allora da quest’ultimo punto: al Polo Sud, noto anche come Antartide. Più precisamente sulla stazione di ricerca Concordia, dove la temperatura media annuale è di -54° e durante l’inverno artico oscilla tra i -70° e i -80°, «ma quella percepita, complice il vento, è ancora più bassa di una buona decina di gradi, mentre nelle giornate più “calde” dell’anno il termometro sale fino -35°/-30°», tiene a precisare il diretto interessato. «Sono una persona normalissima, che ha però avuto la fortuna di vivere un’esperienza al di fuori dalla realtà quotidiana». A cominciare dal suo «ufficio» estivo: un angusto corridoio scavato nella neve, a 15 metri di profondità, a -54°.
Il nostro interlocutore torna poi sui momenti adrenalinici che gli hanno dato queste sue prime tre volte in Antartide: «Di adrenalina ne ho provata fin dal primo momento: già quando sono stato selezionato per la mia prima missione, ho sentito esplodere dentro di me mille emozioni. E lo stesso è successo quando mi hanno chiamato la seconda e la terza volta: anche se sai che laggiù, quando sarai al Polo Sud, ti ritroverai a fare le stesse cose della prima volta, non puoi non provare un’emozione particolare; questa è e rimane un’esperienza adrenalinica dall’inizio alla fine. Quando, la prima volta, mi sono imbarcato sul volo che dall’Italia mi portava fino in Nuova Zelanda, prima tappa del mio viaggio in Antartide, avevo le vene che pulsavano… Un altro momento forte è stato quando il Basler, un piccolo velivolo che fa la spola dalla costa dell’Antartide a Concordia, ha lasciato la base italo-francese: a quel punto inizia il tempo dell’isolamento più assoluto, per nove mesi. O, ancora, quando al termine di quel periodo, ho sentito in lontananza il rombo del motore dello stesso velivolo che tornava a Concordia. Indelebile e carico di emozioni, infine, è pure stato il momento di lasciare la base dopo tutto quel tempo».
Partiamo… dall’inizio: cosa ha portato Marco Buttu, impiegato all’Istituto Nazionale di Astrofisica, in Antartide? O, meglio, come ci è arrivato? «Per puro caso, quasi. Un giorno, ho sentito due colleghi che parlavano di questo progetto in Antartide e del fatto che cercassero persone. Così, spinto dalla curiosità, ho deciso di candidarmi, pur non conoscendo tutti i dettagli. Al punto che ero convinto che l’incarico fosse per un paio di mesi… Qualche giorno dopo ho ricevuto una mail che mi informava che stavano valutando il mio profilo. È a quel punto che sono andato a rileggere di fino i dettagli della missione, scoprendo che si parlava di una spedizione di… un anno e due mesi!». Così, nell’autunno del 2017 inizia la prima delle tre avventure di Marco Buttu al Polo Sud.
Di cosa si occupano le tredici persone che sull’arco dell’anno popolano stabilmente Concordia? «Essenzialmente di ricerca. Sono molteplici i campi in cui ci muoviamo: dalla glaciologia alla sismologia. Ma anche per conto dell’Agenzia spaziale europea, perché le condizioni di vita e dunque di resistenza del corpo umano in Antartide sono simili a quelle degli ambienti extraterrestri. I nostri vicini più prossimi, i tredici specialisti della base antartica russa Vostok, sono a 560 km».
Tutt’attorno c’è un deserto. Non di dune di sabbia, ma del bianco candore della neve ghiacciata, mentre sotto i nostri piedi c’è uno strato di ghiaccio di circa 3000 metri. E, ovviamente, c’è tanto silenzio». Ma anche un gioco di luci e ombre, con una notte che dura cento giorni, durante i quali il sole semplicemente non sorge. «Complice il freddo, poi, l’aria è estremamente rarefatta, cosa che di notte si traduce in apnea del sonno almeno una volta al minuto».
Ed è un’aria anche particolarmente secca, cosa che complica ulteriormente la missione: «Il tasso di umidità relativa oscilla tra il 10 e il 13%. Durante la mia prima spedizione, mi sono fatto un taglietto al pollice destro, una bazzecola, che normalmente si sarebbe cicatrizzata in qualche giorno. A Concordia, tuttavia, ci ha impiegato tre mesi! In quelle condizioni, se dimentichi tipo un’arancia fresca su un tavolo, puoi star certo che l’indomani la ritroverai rinsecchita. Ma non c’è inquinamento luminoso, cosa che permette un’osservazione astronomica ideale, specie negli oltre tre mesi senza sole. Durante il mio secondo inverno a Concordia, ad esempio, abbiamo confermato l’esistenza di un pianeta che non poteva essere scorto da altre parti del mondo».
Come si vive a «bordo» di Concordia? «La base è fondamentalmente composta da due padiglioni. C’è quello riservato a tutte le nostre attività, sia di lavoro, sia ricreative, e poi c’è la “torre del silenzio” dove, proprio perché i cicli circadiani vengono stravolti, possiamo riposarci e dove è appunto vietato ogni rumore. Abbiamo alcune regole di convivenza, poche ma essenziali. I pasti, ad esempio, vengono consumati sempre in comune: ognuno ha compiti e ruoli vitali per la riuscita della missione, per cui, trovandoci, ci sinceriamo che tutto sia sotto controllo».
Come si trascorre il tempo libero a Concordia? «Mi piace scrivere, non a caso da questa esperienza ho ricavato il libro Marte Bianco – Un anno ai confini della vita (Lswr, 2019), a cui quest’anno si è aggiunto il secondo “capitolo”. O pratico yoga: mi aiuta, perché mi permette di rifocalizzare la mia persona. A volte, specie se si deve convivere con altre persone in uno spazio così limitato e per un anno intero, volenti o nolenti, è necessario “ricalibrarsi”».