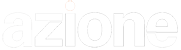Storie di detenuti che attraverso la scrittura si riscattano e svelano le contraddizioni di un sistema carcerario opaco
New York — Lyle C. May vive da venticinque anni nel braccio della morte in un penitenziario della Carolina del Nord, ma la sua cella angusta non è riuscita a spegnergli la voce. Condannato quando era poco più che ventenne per un duplice omicidio, che continua a negare di aver commesso, in carcere si è laureato, ha studiato diritto per corrispondenza e si è trasformato in uno degli scrittori-detenuti più autorevoli d’America. La sua prosa, che sia in forma di reportage o memoir, riempie giornali e riviste, e circola oggi nei corsi universitari.
PEN America
Non si tratta di un’eccezione. May è la punta visibile di un mondo nascosto, popolato da autori che scrivono in condizioni estreme e che, senza aiuti esterni, non avrebbero voce. Ed è proprio per permettere a questi talenti di germogliare che entrano in gioco strutture come quella guidata da Malcolm Tariq, a capo del Prison and Justice Writing Program dell’organizzazione PEN America che da decenni offre strumenti, visibilità e percorsi professionali a decine di reclusi. Il programma, ci spiega Tariq, affonda le radici nell’esplosione della celeberrima rivolta di Attica, nella maxi-prigione dello Stato di New York, nel 1971. «Un evento spartiacque: quattro giorni di proteste che chiedevano ciò che avrebbe dovuto essere scontato, ovvero istruzione, attività formative, cibo decente, condizioni di vita umane». Quella scossa spinse PEN America a muoversi. «Decisero di offrire agli uomini di Attica uno spazio per raccontarsi e crearono un concorso di scrittura». Ogni anno da allora arrivano centinaia di testi dagli istituti di pena di tutto il Paese.
«Oggi il proposito si è ampliato: da un lavoro centrato sulle capacità di scrittura a un’iniziativa che costruisce percorsi professionali, aiutando le persone a crearsi una carriera, un reddito e a sostenere le proprie famiglie anche durante il periodo di reclusione», afferma il responsabile. «Non siamo l’unica realtà in questo campo, come noi ci sono altre organizzazioni che funzionano quasi come agenzie per incarcerati, seguono il loro lavoro, gestiscono le proposte editoriali e i rapporti con gli editor». Il suo ente, PEN America, è la sentinella della libertà di espressione negli Stati Uniti, una non profit nata per difendere dalla censura scrittori, giornalisti e artisti.
«Lavorare con tanti autori straordinari è una continua fonte d’ispirazione», riferisce Tariq. «Studio i loro testi chiedendomi come riescano a creare certi passaggi. La qualità è altissima, spesso di una profondità sorprendente. E quando conosci le loro storie personali e afferri come queste formino lo stile, l’impatto è ancora più forte». Eppure, aggiunge, la forza di quelle pagine non ha bisogno di spiegazioni: «La stesura, da sola, basterebbe».
Contatti e opportunità
Quando lo raggiungiamo, Tariq sta lavorando al nuovo Incarcerated Writers Bureau, una piattaforma digitale che apre un varco tra le celle americane e il mondo dell’editoria, costruito per dare a chi scrive in prigione ciò che di solito non ha: contatti e soprattutto un’opportunità. Al momento ci sono già ventuno artisti, da una costa all’altra, che grazie al sito possono confrontarsi con gli addetti ai lavori. «Lo scopo del sito è promuovere inclusività nella comunità letteraria, in modo da ridurre la divisione tra scrittori dietro le sbarre e scrittori liberi», ci dice. Il database non offre solo nomi e profili. Chiarisce come parlare con un saggista che non ha sempre un computer, come gestire l’editing per posta, ma anche come pagare un detenuto. Permettere agli autori di essere retribuiti in carcere, sottolinea, non è un dettaglio tecnico. «È il cuore del problema. Come si invia denaro a una persona reclusa? E soprattutto: perché è fondamentale farlo? Perché la vita in custodia costa cara. Una persona mi ha raccontato di essere obbligata a un lavoro interno e di guadagnare dieci centesimi al giorno».
Negli Stati Uniti, donne e uomini spesso entrano nel sistema giudiziario quando sono ancora molto giovani. Non sono pienamente formate come adulti. Quando si cresce in un luogo come la galera, mettere tutto su pagina diventa un processo catartico. «Arrivano alla letteratura per dare un senso alla propria vita e al mondo che le circonda. A volte scrivono per sfuggire all’ambiente fisico in cui vivono». Grazie a organizzazioni come PEN e ad altre risorse, possono entrare a far parte di una comunità più ampia. Molti dei narratori presenti nell’Incarcerated Writers Bureau hanno già delle pubblicazioni all’attivo. «Quasi la metà di loro ha dato alle stampe dei libri. Uno, nel braccio della morte, ne ha pubblicati due solo l’anno scorso. Un altro mi ha chiamato questa mattina: pure lui è in attesa di esecuzione, ma ha già diversi titoli alle spalle. Sono tutti talenti nati in carcere».
Come si cucina in carcere
Proprio come Lyle C. May. «È arrivato alla scrittura attraverso la saggistica creativa. Di recente mi ha detto di avere composto perfino delle poesie, che però non pubblica ancora. Il suo libro si intitola “Witness”. Quando l’ho letto, ho cominciato a consigliarlo a tutti», rivela Tariq. Uno stile che ti afferra subito perché mescola narrazione personale e giornalismo. «Lyle descrive, per esempio, come si cucina in carcere, ma allo stesso tempo restituisce le storie degli uomini che stanno per morire e di quelli che sono già morti». Ma il lavoro del detenuto è profondamente influenzato dalle narrazioni più ampie sul sistema giudiziario statunitense. «Un labirinto fatto apposta per non essere capito. Anche chi ha un familiare carcerato spesso non vede tutto: procedure opache, regole che cambiano, decisioni politiche che incidono sulla vita delle persone più di qualunque sentenza. Lyle prova a scoperchiare questo meccanismo. Scrive di leggi, di riforme mancate, di ciò che accade davvero nella Carolina del Nord». Soprattutto, denuncia come la politica determini il destino dei prigionieri. «Molto di ciò che accade alle persone internate dipende da chi viene eletto e da chi vuole un secondo mandato. Se un politico ritiene di poter ottenere più voti aumentando il numero di persone incarcerate, spesso lo farà. È la realtà», affonda il direttore. Lyle C. May conosce questo mondo in ogni minimo dettaglio e riesce a restituirne un affresco perfetto.
I programmi di PEN America favoriscono anche la creazione di uno spazio di dialogo diretto tra studenti e reclusi. «C’è una scuola, il Davidson College, nella Carolina del Nord, dove un professore insegna un corso di letteratura carceraria. Da due anni organizziamo una sessione virtuale con la classe: io partecipo, collego telefonicamente gli scrittori, dando la possibilità agli studenti di fare loro delle domande». Vederli parlare con persone come Lyle, dice Tariq, è la ricompensa più grande. Perché in quel filo di voce che attraversa le sbarre, in quella conversazione tra un’aula universitaria e una cella, c’è forse l’unico antidoto all’opacità del sistema: la possibilità, ancora, di essere ascoltati.