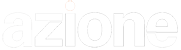Al LAC, una commedia feroce che riscrive gli equilibri del classico Ritorno a casa grazie alla regia di Massimo Popolizio
Chi non ha memoria corta si ricorderà che Ritorno a casa del Premio Nobel Harold Pinter aveva già calcato le scene luganesi, una decina di anni fa, prima ancora che esistesse il LAC, al Palazzo dei Congressi, quindi, con la regia affilata di un fuoriclasse come Peter Stein.
Claustrofobico, scritto sapientemente dalla penna del Premio Nobel con una partitura ricca di velocizzazioni, brusche frenate, pause, rallentamenti, di nuovo velocizzazioni, e per il tramite di una lingua spuria, non esente da volgarità, il testo si sostanzia nel ritorno a casa, come recita il titolo, di uno dei tre fratelli che compongono una famiglia tutta al maschile, misogina e gretta: lui, quello che è andato in America, il professore di filosofia all’Università, e altri due meno raffinati, uomini del popolo, per l’appunto, di cui uno boxeur e l’altro operaio. Compongono il quadro volgare ai limiti dello squallido lo zio e il padre, di professione macellaio, che nella messa in scena vista la scorsa settimana al LAC è interpretato da un eccezionale e in smagliante forma Massimo Popolizio, il quale firma anche la regia.
Rispetto al testo messo in scena da Stein, dove il centro di gravità dello spettacolo era costituito dalla portata immorale della famiglia, e il tono risultava quindi più greve e meditativo, qui il pedale spinge dritto e con una certa convinzione in direzione del grottesco. Squallido e claustrofobico è l’ambiente, un interno casa che vorrebbe essere borghese e ci prova attraverso dettagli come cornici e ornamenti, ma nel complesso risulta solo kitsch e fuori luogo, dominato dal colore rosso che ricorda la professione del padre, la sua violenza, oltre a creare un’atmosfera molto hopperiana. E squallidi sono i personaggi, che, al di là delle pruderie iniziali e del dipinto per tinte sacre della madre, mostrano presto e senza troppi freni la caduta verso la volgarità unita alla visione della donna nei termini della «santa o puttana», tipici della cultura misogina più vieta.
Il ritorno a casa di chi è partito e si è staccato dalla povertà dell’ambiente di origine risulta un vero e proprio incubo, ed è in questa discrepanza che si nota quale sia una delle chiavi di lettura del testo pinteriano, ricchissimo di stratificazioni e denso come tutti i suoi, un’interpretazione suggerita con decisione da Popolizio: il confronto fra classi sociali diverse, e quindi l’immagine non stereotipata e addolcita di ambienti in cui non gira la cultura, in cui il dialogo e la riflessione non sono contemplati, contesti ripiegati su dinamiche perverse e machiste. «Questa è la famiglia», ci diceva Stein, «Questo è un certo tipo di famiglia», ci suggerisce il regista romano, che percorre a grandi falcate il palco, cappellaccio calato sulla testa, nel ruolo del padre e capo, autorità indiscussa di un nucleo sfranto, forse persosi proprio allo sparire della figura materna e femminile, della quale però non sappiamo nulla, anche perché le parole beatificanti del marito e dei figli non possono vantare a ragion veduta nessuna affidabilità.
Si ride, si ride molto per l’intera durata dello spettacolo, anche se la risata è, manco a dirlo, amara. Se inizialmente la compagna del figlio reagisce con timidezza all’ambiente machista, presto – in modo forse troppo repentino, in questa rappresentazione – si adegua ai dettami e va a letto con i due fratelli, di fronte allo sbigottimento e all’impotenza del marito e padre dei suoi figli, che è costretto a fare i bagagli e a tornare solo in America.
Se nella messa in scena di Stein – e nel testo dello stesso Pinter – il dito è puntato contro il pubblico, costituito da una borghesia che tiene alle apparenze ma sotto sotto è composta da detriti e marciume, qui si torna a casa meno angustiati. Le famiglie infelici sono altre, si crede, a torto o a ragione. Una lettura diversa e forse comunque valida, quella di Popolizio, che ha approfittato dei sessant’anni dall’uscita del testo per rispolverare un classico che continua a parlare e che può essere oggetto di interpretazioni diverse.
Il difetto principale di questo spettacolo va ricercato nel repentino cambio di guardia della donna, che senza grandi sfumature e scavi psicologici decide immotivatamente di lasciare la tranquillità della sua posizione per mettersi a capo di un progetto business-oriented legato alla prostituzione con i tre sordidi parenti del marito. La scelta è irragionevole nel testo e lo è ancora di più nella traduzione scenica che abbiamo visto a Lugano. Il motivo, poi, della donna bionda e mozzafiato che infine fa la lap dance si sarebbe potuto evitare, e ottenere (forse) maggiore efficacia. Ruth, personaggio chiave del dramma, andava probabilmente indagata un po’ di più, i suoi nodi andavano sviscerati meglio. In fondo, il personaggio più enigmatico è proprio lei: perché non approfondire quale sia l’attrazione di una donna normale, non troppo bella, per il torbido? Il pubblico ne sarebbe uscito maggiormente arricchito.