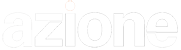Tra il ludico e il dilettevole: l’infanzia è un momento magico dominato dal gioco, dalla fantasia e dall’immaginazione ma, come ci racconta la letteratura, non può durare in eterno
In I giocattoli del bambino e le ragioni dell’adulto, il noto psicologo Erik Erikson sostiene che i giochi dei bambini, lungi dall’essere frivoli, sono un modo per esplorare la realtà e per simbolizzare il mondo interiore. Attraverso il gioco non solo il bambino può sperimentare il mondo, ma il gioco è anche un’importante esperienza socializzante. Giocando, il bambino interiorizza le norme, i ruoli, e i modelli della società.
L’attitudine al gioco del bambino, e la valenza formativa delle attività ludiche, non si limitano però a forme di gioco strutturate, ma investono l’approccio, il rapporto, e lo sguardo con cui il bambino osserva e abita il mondo. Tipico del bambino è, per esempio, il pensiero magico, uno stile di pensiero improntato alla fantasia e intriso di immaginazione che si configura come propedeutico rispetto al pensiero logico-razionale che prevale negli adulti.
Il passaggio dall’uno all’atro non avviene in modo immediato, e anche quando il bambino viene scolarizzato sussistono momenti ed esperienze in cui il pensiero magico viene fortemente sollecitato. Anche da adulti, in fondo, l’attività della fantasia e dell’immaginazione possono essere considerate, da un certo punto di vista, una felice isola in un mondo oltremodo dominato dalla razionalità.
È altresì vero che lo sviluppo psicofisico e cognitivo è un processo irreversibile, ed è per questo che non è mai semplice crescere. Nel migliore dei casi, però, la crescita si configura come una serie di esperienze di apprendimento grazie a cui il bambino acquisisce gradualmente gli schemi di pensiero, di percezione e di costruzione del mondo che lo traghettano verso quello adulto.
La letteratura offre un osservatorio privilegiato per tematizzare questo processo. L’inventore di sogni di Ian McEwan mostra molto bene, per esempio, il rapporto dialettico che intercorre fra l’immaginazione e il reale, fra l’onirico e il concreto. Protagonista è Peter Fortune, un ragazzino di 12 anni con un’incorreggibile inclinazione a trasformare le esperienze quotidiane in sogni a occhi aperti, spesso tanto vividi da sostituire la realtà. Per Peter, fantasia e razionalità non sono forze opposte, ma esistono forme di pensiero che si nutrono dell’una e dell’altra, come l’immaginazione speculativa con cui entra in contatto quando, nel corridoio della sua scuola, ascolta la conversazione fra due alunne più grandi. Una chiede all’amica: «Ma come fai a sapere che adesso non stai solo sognando? Magari stai solo sognando di parlare con me». L’amica risponde che basterebbe darsi un pizzicotto: se le facesse male, si sveglierebbe all’istante. Allora la prima alunna rilancia: «Ma prova a pensare se stessi solo sognando di pizzicarti, e anche di aver sentito male. Potrebbe essere tutto un sogno e tu non lo sapresti mai…». Al cospetto di questo scambio Peter realizza che «quell’idea era venuta in mente anche a lui, ma non era mai riuscito a formularla con altrettanta chiarezza».
La crescita è un viaggio complesso e irreversibile, dove il bambino impara a mediare tra immaginazione e responsabilità
Nel capitolo che chiude L’inventore di sogni, intitolato I grandi, Peter racconta delle vacanze estive con la famiglia sulle spiagge della Cornovaglia, dove incontra altri bambini con cui stringe amicizia in un ambiente allegro dove le attività ludiche, alcune delle quali improvvisate, non mancano mai. Prendendo parte con slancio ed entusiasmo alle scorribande che coinvolgono, a ogni ora del giorno, lui e i suoi nuovi amici, Peter non può fare a meno di notare come gli adulti sembrano, all’opposto, non divertirsi affatto, dediti come sono a occupazioni che paiono decisamente noiose e senza senso. Una sera, però, Peter litiga per un pezzo di cioccolato, e il gruppo di ragazzini, che sembra dargli torto, si allontana lasciandolo solo sulla riva del mare. McEwan aggiunge che «con ogni probabilità», quei ragazzini «si erano già scordati di lui e avevano inventato un altro gioco», come a ricordare l’inesauribile passione ludica dei bambini.
Solo sulla spiaggia, Peter getta un’occhiata dall’altra parte, verso le verande dove gli adulti passano la serata. Riesce a sentire «il mormorio basso delle conversazioni dei grandi, il suono di un tappo di sughero tirato dalla bottiglia, la musica di una risata femminile, forse della sua mamma». E poi, improvvisamente, ha una rivelazione: «Quella sera di agosto, restando lì in mezzo ai due gruppi, con il mare che gli lambiva appena i piedi nudi, Peter all’improvviso afferrò qualcosa di molto ovvio e terribile: un giorno o l’altro, avrebbe lasciato il gruppo che scorrazzava sfrenato lungo la spiaggia, per unirsi a quello di chi restava seduto a parlare. Era difficile crederci, ma sapeva che sarebbe andata proprio così. Allora si sarebbe interessato a cose diverse, come lavoro, denaro, tasse, interessi bancari, chiavi e caffè, e sarebbe rimasto a parlare, per ore e ore, seduto».
Come McEwan, anche lo scrittore palermitano Roberto Alajmo in Il primo amore non si scorda mai, riesce a cogliere e rappresentare il momento di passaggio fra l’infanzia e il mondo degli adulti. Nello specifico, Alajmo ci propone una raccolta di esperienze che hanno costellato la sua infanzia, e che hanno marcato una tappa del suo sviluppo personale. Fra le esperienze narrate, si intravvede una progressione che accompagna i ricordi dell’autore dalla prima infanzia fino all’adolescenza. E c’è anche un ricordo che, più di altri, cristallizza un momento simbolico e fortemente poetico che annuncia, appunto, la fine ineluttabile dell’infanzia.
Siamo, come in McEwan, al cospetto di un’esperienza liminale in cui il fervore dell’immaginazione, tipico dell’infanzia, cede il passo al realismo pragmatico che governa il mondo degli adulti. Racconta, Alajmo, che nel suo villaggio c’era un muro che nessun bambino aveva mai varcato, ma che nondimeno continuava a fornire lo spunto per «un gioco non dichiarato, che consiste nel raccontare minchiate. Possibilmente: minchiate che facciano paura. Molto vivide, perché vince chi convince gli altri a crederci sul serio». E così, a suon di storie inventate ma credibili, la paura e il mistero finivano per dominare quello spazio ignoto al di là del muro. Fino a che, un giorno, un ragazzino, tale Gianni Cirafici, decide di attraversare la soglia, vedere cosa c’è di là.
Fra i coetanei, di cui l’autore fa parte, l’apprensione che accompagna l’impresa è tanta, la tensione è alta, non potrebbe essere altrimenti. E quando, finalmente, Gianni Cirafici ricompare, c’è un attimo di silenzio che sembra infinito. Poi qualcuno comincia a parlare, e gli interrogativi si moltiplicano. Ma in realtà la domanda è solo una: cosa c’è dall’altra parte? Allora Gianni, guardandoli dritto negli occhi, fa un bel respiro e dice: niente. E Alajmo aggiunge: «è stato quel giorno che è finita l’infanzia».