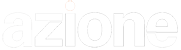Gli attori regionali e non sfruttano la crisi per ridefinire equilibri, rafforzare alleanze e ampliare la loro influenza
La scossa di magnitudo 4.2 che ha svegliato il Paese giovedì scorso non ha trovato impreparati gli israeliani il cui livello di allerta era già estremamente elevato in attesa di una nuova possibile rappresaglia iraniana. Le dichiarazioni di Trump sugli «aiuti in arrivo» per i manifestanti iraniani, insieme agli avvisi ai cittadini stranieri di lasciare il Paese, nonché ai cambiamenti di rotta delle compagnie aeree, suggeriscono infatti un’escalation possibile e nell’ultima settimana la miscela di guerra prolungata, instabilità regionale e iper-esposizione mediatica ha portato l’opinione pubblica israeliana a un nuovo picco di tensione. Le narrazioni dominanti parlano infatti di un Iran sull’orlo del collasso, di un intervento americano «dietro l’angolo» e di una rappresaglia iraniana inevitabile contro Israele ma, se dichiarazioni allarmistiche, analisi televisive ossessive e il trauma collettivo seguito al 7 ottobre hanno contribuito gradualmente ad alimentare il panico collettivo, dalle valutazioni degli analisti emerge un quadro più cauto.
Inaffidabile e capriccioso
Sebbene con l’inaffidabile e capriccioso Trump tutto potrebbe cambiare in un attimo, nelle giornate di martedì e mercoledì nello Stato ebraico non si registravano ancora segnali concreti di un attacco iraniano imminente, non era chiaro se gli Usa fossero davvero pronti a un’azione militare significativa né se le proteste in Iran fossero in grado di rovesciare il regime. Sempre negli stessi giorni, fonti della sicurezza hanno escluso il coinvolgimento diretto di Israele nella pianificazione di un’eventuale operazione militare statunitense contro l’Iran. È possibile che Netanyahu sia informato di tempi e modalità, ma l’assunto operativo era che Washington avrebbe avvisato solo poco prima di un’azione. Anche per quanto riguarda l’intensità dell’attacco, molti in Israele dubitano che avrebbe un impatto reale oltre il valore simbolico.
Trump potrebbe scegliere di agire per ragioni di immagine o politica interna: mantenere una promessa, mostrarsi forte, distinguersi dalla prudenza dei predecessori o semplicemente esercitare pressione in vista del raggiungimento di un accordo. L’esperienza insegna che neppure massicce campagne di bombardamento hanno scalfito il controllo del regime iraniano, capace di mantenere il potere anche sotto attacchi diretti e, senza una presenza militare estesa e continuativa nella regione, difficilmente gli Stati Uniti potrebbero alterare gli equilibri interni iraniani. Anche l’ipotesi di un attacco iraniano contro Israele è considerata improbabile senza una provocazione diretta. Teheran non avrebbe alcun interesse ad aprire un nuovo fronte e le minacce contro Tel Aviv servirebbero soprattutto come deterrenza verso Washington per alzare il costo percepito di un’azione americana. Tuttavia in una regione instabile come il Medio Oriente, considerando anche la scarsità di informazioni dovute al blackout dell’internet iraniano e alla sanguinosa repressione dei manifestanti da parte del regime, le valutazioni possono cambiare rapidamente e Israele ha rafforzato in modo significativo le proprie difese avviando misure preventive su larga scala sul piano civile, militare e dell’intelligence.
La stessa opportunità di un intervento militare, americano o israeliano, mentre le proteste sono in corso, è di per sé argomento controverso. Anche senza risalire alla memoria storica del colpo di Stato del 1953, che pesa ancora profondamente sull’immaginario collettivo, la diffidenza del popolo iraniano verso ogni promessa di «liberazione» dall’esterno è emersa anche nel corso dei 12 giorni di bombardamenti da parte di Israele e Usa nel giugno scorso. Una nuova ingerenza militare rischierebbe secondo molti di rafforzare il regime consentendogli di presentare il dissenso interno come un complotto straniero, o, nella migliore delle ipotesi, di sostituirlo con uno più «addomesticabile» che non per forza garantirebbe stabilità e benessere alla popolazione locale. Se così fosse, a guadagnare dall’operazione sarebbero sostanzialmente gli attori esterni, tra cui Trump e Netanyahu, il quale ultimo collezionerebbe mandate e consensi preziosi in vista delle elezioni previste alla fine di quest’anno. Non a caso Israele cerca di dissuadere gli Stati Uniti dal tentare la carta diplomatica sfruttando la debolezza e l’isolamento del regime iraniano umiliato, delegittimato e costretto a confrontarsi con una catastrofe ambientale e un collasso economico senza precedenti.
Ipocrisia israeliana
Per comprendere l’ipocrisia israeliana è sufficiente dare uno sguardo ai principali canali d’informazione, la cui copertura mediatica delle proteste iraniane ricompatta come sempre l’opinione pubblica ebraico sionista la quale, di fronte al nemico esterno per antonomasia, si spoglia di ogni connotazione politica. A destra gli israeliani esultano per le manifestazioni contro Khamenei, mentre minimizzano, delegittimano o demonizzano quelle contro il Governo Netanyahu. A sinistra la narrazione bellica permanente diventa uno strumento politico che distoglie l’attenzione dalla crisi democratica interna rafforzando la logica dell’emergenza che annulla le divisioni. In questi giorni anche siti di informazione israeliani di centro sinistra criticano l’indifferenza delle piazza del mondo nei confronti della repressione e dei morti alle proteste iraniane, alludendo al silenzio dei movimenti pro palestinesi che avrebbero invaso piazze e università a favore di Gaza mossi dall’elemento coloniale assente nel caso iraniano.
Va da sé che, a differenza delle manifestazioni israeliane degli ultimi anni, spesso caratterizzate da leadership organizzate, rivendicazioni mirate e dinamiche interne alla cultura politica democratica israeliana incentrate sulla governance e sulle istituzioni, le proteste iraniane rappresentano un fenomeno di grande importanza simbolica, etica e politica che, insieme a singoli diritti economici o civili, rivendica un cambiamento politico radicale profondo dove valori come dignità, autonomia personale e verità stanno diventando principi mobilitanti.
L’ossessione per l’Iran maschera dunque anche all’interno le sempre più profonde fratture e contraddizioni della società israeliana. Benché le infrastrutture civili colpite nel corso della guerra, come l’ospedale Soroka e l’Istituto Weizmann, attendano invano di essere risanate, lo Stato di diritto venga progressivamente eroso dalla riforma giudiziaria, l’esercito supporti i crimini dei coloni ebrei contro i palestinesi in Cisgiordania e quel che resta della democrazia e del potere giudiziario venga progressivamente smantellato, l’attenzione della società ebraica resta ostinatamente rivolta altrove, intrappolata in una politica della paura che produce molto rumore, ma pochissime certezze. L’ impegno collettivo iraniano è ben diverso dalle proteste israeliane del sionismo liberale ancora militarizzato e quasi impermeabile al tema dell’occupazione infatti, come ha commentato amaramente Yasmin Levy sul quotidiano «Haaretz», mentre in Iran «si combattono con forza gli ayatollah sciiti, qui (in Israele) si ospitano nei talk show gli ayatollah del sionismo religioso e di Otzma Yehudit (partito dell’estrema destra religiosa, razzista e ultranazionalista».