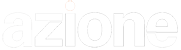Come Italia e Svizzera hanno raccontato il caso tra invadenza giornalistica, rispetto della privacy e generalizzazioni
Crans-Montana e l’informazione: una relazione che, al di là dei risvolti giudiziari, ci interroga come cittadini, come destinatari di un flusso incessante di notizie che scandisce le nostre giornate dall’alba al tramonto, e anche durante le ore notturne (per gli insonni). Non c’è sosta, non c’è interruzione. L’informazione non dorme mai, proprio come il denaro («money never sleeps»). Il flusso tuttavia non è regolare, conosce picchi e accelerazioni improvvise. Accade in caso di conflitti bellici imprevisti, catastrofi, disgrazie. È in questi momenti che l’indifferenza per un mondo che comunque va male lascia il posto all’attenzione, al bisogno di sapere e di capire.
Un’offerta ricca
Il caso di Crans-Montana è per certi versi paradigmatico: è una tragedia destinata a diventare un caso di studio per i giornalisti, e anche materia di ricerca per le Facoltà universitarie. Per la sua gravità e per le sue implicazioni sovranazionali, ha mobilitato risorse umane e materiali inusuali per le nostre latitudini. Ma ha pure evidenziato l’esistenza di scuole diverse per approccio, linguaggio, uso delle immagini, frutto di culture giornalistiche maturate in sistemi mediatici non omogenei: stampa, media elettronici, canali sociali.
La Svizzera italiana è notoriamente un poggiolo aperto sull’Italia. Non c’è ostacolo o frontiera che possa arginare o selezionare i segnali radiotelevisivi che ci giungono dalla penisola, prodotti dalla Rai (emittente pubblica) o da Mediaset (azienda privata). È un’offerta che ci arricchisce e che, generalmente, apprezziamo. Abbiamo a disposizione un numero cospicuo di canali e programmi, e quindi abbiamo la possibilità di raffrontare la qualità delle notizie diffuse sia dalla nostra Rsi sia dalle reti italiane.
Due filosofie opposte
Questa ricchezza informativa non è però priva di ombre. Nel caso concreto, non si può dire che talune reti italiane, in primo luogo Rai 2 e Rete 4, abbiano dato prova di professionalità e di sobrietà: troppe le sbavature e le imprecisioni, unite alla curiosità morbosa per gli aspetti più raccapriccianti. Qui noi, come telespettatori, abbiamo potuto misurare la distanza tra le due deontologie, quella italiana e quella elvetica. Da questo lato della frontiera il riserbo, la prudenza, la discrezione, il segreto elevato a principio ordinatore universale; dall’altro lato servizi realizzati senza impiegare filtri per nomi e volti. Due filosofie quasi opposte di concepire l’informazione.
Il codice deontologico elvetico è senz’altro più rispettoso della sfera privata. La tutela della persona è pressoché totale, fatta eccezione per le figure che ricoprono cariche pubbliche (per esempio i politici) o che sono note al grande pubblico (attori, sportivi ecc.). Solo in questo caso è possibile rendere note le generalità. Altrimenti silenzio. Silenzio anche per i condannati in via definitiva, per i pedofili, per i truffatori dal colletto bianco. Perciò i cronisti sono costretti, per non divulgare i nomi, a ricorrere a laboriose perifrasi o a limitarsi all’età: un ventenne, un settantenne… con risultati spesso grotteschi. Sono appropriate queste regole o sono troppo restrittive? La questione circola da tempo tra i giornalisti. Allentarle non è facile, perché spesso svelare un nome (come nel caso di un pedofilo) vuol dire arrivare all’identità delle vittime, che vanno tutelate. Le norme intendono pure scongiurare la tentazione di istruire un processo a mezzo stampa o di allestire una gogna pubblica, come avveniva nel Medioevo. Il legislatore ha pure contemplato un diritto all’oblio, una volta scontata la pena.
Il Consiglio svizzero della stampa ha condannato i metodi adottati da alcuni canali televisivi italiani nel raccontare la tragedia di Crans-Montana. Metodi che invece hanno incuriosito e attratto molti telespettatori italofoni, e dunque anche ticinesi, che sulle reti dei nostri vicini sono andati a cercare proprio quelle indiscrezioni che la Rsi tendeva a celare per le ragioni sopraddette. Lo stesso si può dire per i social, che sono diventati un’enorme cassa di risonanza in piena libertà (o licenza) dove ciascuno ha potuto raccontare e illustrare la propria verità, senza verifica alcuna.
Tutti colpevoli
L’altro aspetto che qui si vorrebbe brevemente affrontare è quello della generalizzazione: nel caso specifico, l’accusa rivolta non a questo o quell’esercente, non a questo o quell’amministratore, ma a tutti gli svizzeri, o a tutti i vallesani. Una colpa dunque collettiva, come se un’intera comunità fosse in qualche modo corresponsabile della sciagura. Ragionare per macro-categorie è una tentazione ricorrente, che risale all’Ottocento con la creazione degli Stati nazionali e parallelamente con la diffusione della stampa. È in questo contesto, nel moto di un crescente ed aggressivo nazionalismo, che nella coscienza popolare si sono fatti largo pregiudizi e stereotipi: i tedeschi arroganti, i francesi boriosi, gli italiani cialtroni. La propaganda bellica ne farà un uso spregiudicato per tutto il Novecento.
E gli svizzeri? Opportunisti dietro lo scudo della loro neutralità, pedagoghi con il dito puntato, ripulitori di denaro sporco… Non sorprende dunque che nelle cronache di questi giorni sia ricomparso questo vecchio repertorio, innescando tra l’altro una girandola di ripicche: «e voi allora?». Sorprende invece che alcuni celebri giornalisti abbiano rinunciato all’esercizio critico per farsi portavoce dei più banali luoghi comuni. Pensiamo in particolare a Beppe Severgnini (sentito su La7), che dovrebbe conoscere bene la Svizzera, la sua diversità, la sua multiforme composizione demografica, la sua varietà linguistica e culturale. Ma al festival della condanna in contumacia hanno partecipato in molti, con sortite anche offensive, del tutto gratuite (l’ex senatore Tommaso Cerno, ora direttore del «Giornale», Paolo Del Debbio, conduttore di Rete 4).
L’istinto e la ragione
Un antidoto a tutto questo ci sarebbe, ma non riesce a far breccia nell’attuale brusio informativo: è quello che invita all’auto-analisi e all’introspezione, senza rovesciare primariamente sull’altro le proprie insoddisfazioni o tare storiche. Pensiamo a Leopardi, con le sue riflessioni «sopra i costumi degli italiani», a Giuseppe Prezzolini, ad Ennio Flaiano, a Giorgio Bocca. O pensiamo ai nostri Max Frisch e Peter Bichsel (indimenticabile l’operetta La Svizzera dello svizzero). Abbandonarsi alle reazioni istintive è più facile che affidarsi al ragionamento fondato sulle distinzioni e sull’accertamento delle responsabilità, sia di individui singoli, sia di istituzioni pubbliche, comunali e cantonali. Senza sconti e senza insabbiamenti.