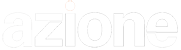A Milano l’HangarBicocca ospita i lavori della fotografa statunitense
Che la fotografia di Nan Goldin abbia tutt’altra intensità e qualità rispetto a quella che, ispirandosi ai suoi lavori, si è diffusa un po’ ovunque sulle pagine patinate delle riviste giovanili degli ultimi quarant’anni, a partire da «I-D» e «The Face», i visitatori della mostra dedicata all’artista americana attualmente in corso all’Hangar Bicocca a Milano, lo capiscono quando, salite le scale che permettono di accedere all’installazione con cui si chiude la mostra, vengono precipitati nel cuore stesso della sua intima e tragica esperienza familiare.
Realizzata nel 2004 per la cappella dell’ospedale La Pitié-Salpêtrière a Parigi, dove nell’Ottocento Jean-Martin Charcot aveva compiuto i suoi studi sull’isteria femminile, Sisters, Saints, Sibyls è un’installazione multimediale in cui alcuni elementi scultorei e una proiezione video a tre canali affrontano il tema della sofferenza legata alla condizione femminile nella nostra società a partire dalla drammatica vicenda dalla sorella dell’artista morta suicida a 18 anni dopo essere stata ricoverata in un istituto psichiatrico. Nell’opera, il racconto della vita di Barbara Goldin, caratterizzata da ribellioni e conflitti con la morale perbenista del tempo, si intreccia con la storia di Santa Barbara, uccisa dal padre perché convertitasi al cristianesimo, e con la rievocazione dell’adolescenza dell’artista segnata profondamente dal trauma provocato dalla morte della sorella quando lei aveva appena undici anni.
Questo tragico episodio attorno a cui ruota il capitolo finale della mostra milanese ci riporta direttamente agli inizi del percorso artistico di Nan Goldin (all’anagrafe Nancy Goldin) quando sul finire degli anni Sessanta, abbandonato l’ambiente famigliare che sentiva direttamente coinvolto e in qualche modo riteneva colpevole della morte della sorella, approda nelle aule della Satya Community School, una scuola libertaria improntata al modello della Summerhill School. Alla Satya, la Goldin muove i primi passi nel campo della fotografia assieme a un compagno di classe, David Armstrong, con il quale proseguirà poi gli studi presso la scuola del Fine Arts Museum di Boston e con il quale sarà legata da una profonda amicizia per tutta la vita.
Se la scoperta di questo mezzo espressivo è stata del tutto fortuita – per scopi promozionali la Polaroid aveva regalato alla scuola alcuni apparecchi fotografici – la passione con cui la giovane ragazza nata a Boston si buttò su di essa fu direttamente proporzionale alla consapevolezza che la fotografia potesse diventare la medicina se non per guarire almeno per lenire le profonde ferite del suo animo. In quell’«è stato», nel quale Barthes ha identificato il noema, ossia l’essenza della fotografia, Nan Goldin ha capito che risiedeva la possibilità di conservare una traccia del proprio passato, di far rivivere chi non c’è più e allo stesso tempo di dare rappresentazione e quindi dignità anche a chi sta ai margini, ai reietti, ai diversi, a chi sfugge o si oppone alle rigide maglie del conformismo sociale.

Nan Goldin
My mother pregnant, n.d.
© Nan Goldin
Courtesy Gagosian
La fotografia non è però come il cinema, altra grande passione dell’artista in quegli anni giovanili. Non permette di costruire storie lineari, di sviluppare racconti coerenti, di mimare il flusso dell’esistenza. Le immagini fotografiche condividono con la memoria una natura fatta di istanti congelati, di epifanie improvvise ma isolate e frammentarie. Anche quando le si dispone in sequenza, tra un’immagine e l’altra rimane sempre uno iato, una distanza che lo spettatore è chiamato a riempire. Tuttavia è proprio questo carattere ellittico della narrazione fotografica a interessare l’artista e a spingerla alla fine degli anni Settanta a sviluppare una modalità di presentazione dei propri lavori che è diventata nel tempo la sua cifra stilistica.
Una modalità che sta a metà tra la fotografia e il cinema e che si incarna nello slideshow. Nella mostra di Milano, che si colloca nel quadro di una collaborazione internazionale nata nel 2022 su iniziativa dal Moderna Museet di Stoccolma a cui si sono associati, oltre all’Hangar Bicocca, lo Stedelijk di Amsterdam, la Neue Nationalgalerie di Berlino e il Grand Palais di Parigi, non vi è nessuna stampa fotografica su carta. Le serie fotografiche della Goldin sono infatti presentate sottoforma di proiezioni di diapositive digitali accompagnate quasi sempre da una colonna sonora musicale all’interno di piccole strutture architettoniche espressamente concepite per la mostra dall’architetta Halé Warde.
La prima di queste serie, e indubbiamente la più conosciuta, è The Ballad of Sexual Dependency, il cui titolo deriva dall’Opera da tre soldi di Brecht. Si tratta di un insieme di oltre settecento immagini scattate tra i primi anni Settanta e la metà degli anni Ottanta all’interno della cerchia di amici e conoscenti che la Goldin frequentava a New York dove si era trasferita nel 1978. Persone che facevano parte della sottocultura giovanile di quel periodo e in particolare del mondo delle drag queen e delle comunità lesbiche e gay che animavano la vita notturna nell’East Village e a Bowery.
Sono scatti che, come ha affermato l’artista, scaturiscono direttamente dalla sua vita, che «nascono dalle relazioni, non dall’osservazione». A differenza di Diane Arbus, e delle sue fotografie di drag queen di un decennio prima, da cui è stata indubbiamente influenzata, Nan Goldin non si è mai posta di fronte al mondo che ritraeva come un osservatore esterno, distaccato. Lo dimostra anche il suo impegno come attivista a favore delle vittime dell’AIDS e degli oppioidi usati in ambito farmaceutico. Tutta la sua opera in fondo non è altro che un enorme diario della sua vita, dei suoi incontri, delle sue amicizie, dei suoi amori, delle sue sofferenze e delle sue dipendenze. Un diario intimo, a volte crudo, come nella fotografia del 1984 in cui la vediamo con ancora sul volto i segni del pestaggio a cui l’aveva sottoposta un mese prima il suo compagno di allora, ma in cui si avverte un’empatia profonda e totale per l’umanità che ritrae.
L’approccio e soprattutto lo stile fotografico iniziale di Nan Goldin deve molto a Tulsa di Larry Clark, un libro fotografico del 1971 da cui hanno tratto ispirazione molti artisti nei decenni successivi. Anche quello un libro che racconta storie che «non vanno a finire bene», come recita il titolo di questa mostra che allude ironicamente al destino che attende ogni essere vivente. Tuttavia, visto che per Nan Goldin il personale è politico, in questo titolo si può forse cogliere anche il timore di fronte a una situazione mondiale in cui i conflitti e l’autoritarismo dilagano sempre più.