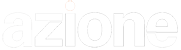Dal caso della Makhteret Yehudit alle tensioni dell’Israele di oggi: radicalizzazione e fragilità istituzionali di una realtà sempre in bilico
Il documentario The Jewish Underground (Shai Gal, 2017), di recente trasmesso dalla piattaforma israeliana Yes, ha riportato alla luce la storia della Makhteret Yehudit, una cellula clandestina ebraica attiva tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta del Novecento. Si tratta di una sorta di thriller politico-investigativo che, attraverso interviste e ricostruzioni fattuali e processuali, racconta la storia di come i membri della più grande organizzazione terroristica di coloni israeliani di destra abbiano finito per diventare una potenza dominante all’interno dell’attuale Governo israeliano.
Mosse tanto dall’ideologia religiosa, quanto dalla percezione di minaccia e da un senso di inefficacia dello Stato, le azioni attribuite alla cellula includono un attentato contro tre sindaci palestinesi nel giugno 1980 e un attacco del luglio 1983 allo Islamic College di Hebron, in cui tre studenti furono uccisi e 30 feriti. Per lo studioso Menachem Klein (Settlements and Power, 1995) eventi come il massacro all’accademia talmudica di Hebron nel maggio 1980, in cui 6 studenti ebrei furono uccisi e 16 feriti, rafforzarono la convinzione tra alcune comunità religiose nazionaliste che fosse moralmente giustificato agire in autonomia, in assenza di protezione statale. Le indagini dei servizi di sicurezza israeliani richiesero mesi per identificare i responsabili che pianificavano tra le altre cose di colpire la Cupola della roccia di Gerusalemme, luogo santo musulmano per eccellenza. Il processo, tenutosi nel 1984, portò alla condanna di 15 membri su 29, con tre condanne all’ergastolo.
Legami con gli Usa
Tra i simpatizzanti e sostenitori dei detenuti si annovera il rabbino di origini algerine Yehuda Leon Ashkenazi («Manitou») che considerava la statualità promossa dai leader sionisti religiosi come ipocrita rispetto alle scelte delle istituzioni da lui definite diasporiche e umilianti. L’atteggiamento sovrano di conquista e dominio sulla Terra d’Israele senza esitazioni né ritirate auspicato da «Manitou» trovò invece una forte opposizione nel rabbino di origini austriache Zvi Tau e dai rabbini di quelle che in seguito furono chiamate le «Yeshivot HaKav», i quali sostennero che l’uso degli scritti del rabbino Abraham Isaac Kook – che aveva lavorato per fondare il concetto di statualità in Israele – per minarla dall’interno fosse falso e fuorviante. Inoltre, secondo le indiscrezioni di allora, tra i finanziatori della clandestinità vi sarebbero stati alcuni gruppi cristiani evangelici statunitensi che avrebbero trasferito ai suoi leader milioni di dollari, come avviene ancora oggi rispetto alle colonie ebraiche in Cisgiordania.
Alla fine tuttavia, come riportano i giuristi Mordechai Kremnitzer e Yoram Rabin nel loro Il processo della Makhteret Yehudit (1990), pressioni sociali e tensioni politiche contribuirono a ridurre le pene portando alla scarcerazione entro la fine degli anni 90 della maggior parte dei condannati. La rappresentante della Procura dello Stato, Dorit Beinisch, presentò allora ricorso alla Corte Suprema contro la leggerezza delle pene inflitte a 5 dei condannati, ma il ricorso fu respinto nell’aprile 1986. Come se non bastasse, alcuni degli imputati ricoprono posizioni di consulenza o ruoli pubblici nell’attuale Governo a dimostrazione di come la società israeliana sia in grado di reintegrare individui ai margini della legalità, soprattutto nel contesto religioso-nazionalista (Tamar Hermann e Daniel Monterescu, Società e religione in Israele: integrazione dei margini, 2010).
Nel Paese cresce la povertà
L’identificazione di parte dell’opinione pubblica con la vicenda della cellula clandestina ebraica e le sue conseguenze offrono dunque una lente preziosa proprio per comprendere i dilemmi d’Israele oggi, partendo dalla radicalizzazione politica e religiosa quale fenomeno intrecciato al contesto sociale, fino ai limiti e all’ambiguità dell’apparato giudiziario. Dopo la «tregua» mediata dagli Usa e il ritorno degli ostaggi, il Paese attraversa una fase di transizione segnata da instabilità e forti tensioni interne, destinate ad inasprirsi in vista delle possibili elezioni previste per la fine del 2026. L’istituzione di adeguate commissioni d’inchiesta sui fallimenti della guerra è osteggiata da Netanyahu che persiste nel mantenere aperti molteplici fronti di conflitto con diversi Paesi della regione. Tale percezione di precarietà all’interno del Paese trova conferma nella crescita della povertà, nel caro vita, nell’inefficienza cronica del sistema sanitario, i cui servizi pubblici di salute mentale non riescono a far fronte alla domanda, e nell’espatrio di professionisti, provenienti soprattutto dai settori scientifici e dell’high tech. Nel corso della visita del premier israeliano della settimana scorsa, il presidente americano ha ribadito la richiesta di grazia al presidente Herzog rispetto al processo di corruzione a carico di Netanyahu appoggiandone anche la linea dura contro l’Iran qualora la minaccia nucleare si ripresenti concretamente.
Così facendo, Trump ha ulteriormente spiazzato gli israeliani che contavano sulla sua mediazione per stabilizzare la sicurezza e procedere alla fase due della tregua che prevedeva il disarmo di Hamas e la ricostruzione di Gaza. Tutto questo si riflette naturalmente anche nella politica interna israeliana che resta polarizzata. L’ambiguità delle componenti ebraiche dell’opposizione nei confronti dei partiti arabi, le tensioni con gli ultraortodossi per l’esonero dalla leva obbligatoria e l’avanzamento della riforma giudiziaria – che include l’introduzione della pena di morte a carico dei presunti terroristi e la nomina di figure controverse, come l’attivista dell’estrema destra nazionalista Zvi Succot, a capo della Commissione parlamentare per l’istruzione – accentuano le divisioni culturali e politiche. Ripiegata su se stessa e perennemente concentrata su scandali interni, fratture politiche e culturali, la società ebraica israeliana si sottrae così al dialogo con le accuse esterne per tutto ciò che concerne le politiche di occupazione e pulizia etnica, scegliendo di respingere acriticamente ogni forma di boicottaggio.
La tensione sociale si manifesta anche in episodi quotidiani di razzismo e discriminazione nei confronti di autisti, netturbini e lavoratori palestinesi, aggressioni queste ultime che raccontano quanto la percezione di sicurezza, la giustizia e l’uguaglianza siano questioni ancora irrisolte. In questo intreccio di passato e presente, The Jewish Underground non è solo un documentario storico, bensì uno strumento di analisi per comprendere quanto i confini tra legalità, consenso sociale e valori morali nello stato ebraico siano fragili e soggetti a pericolose contrattazioni su base etnico-religiosa.