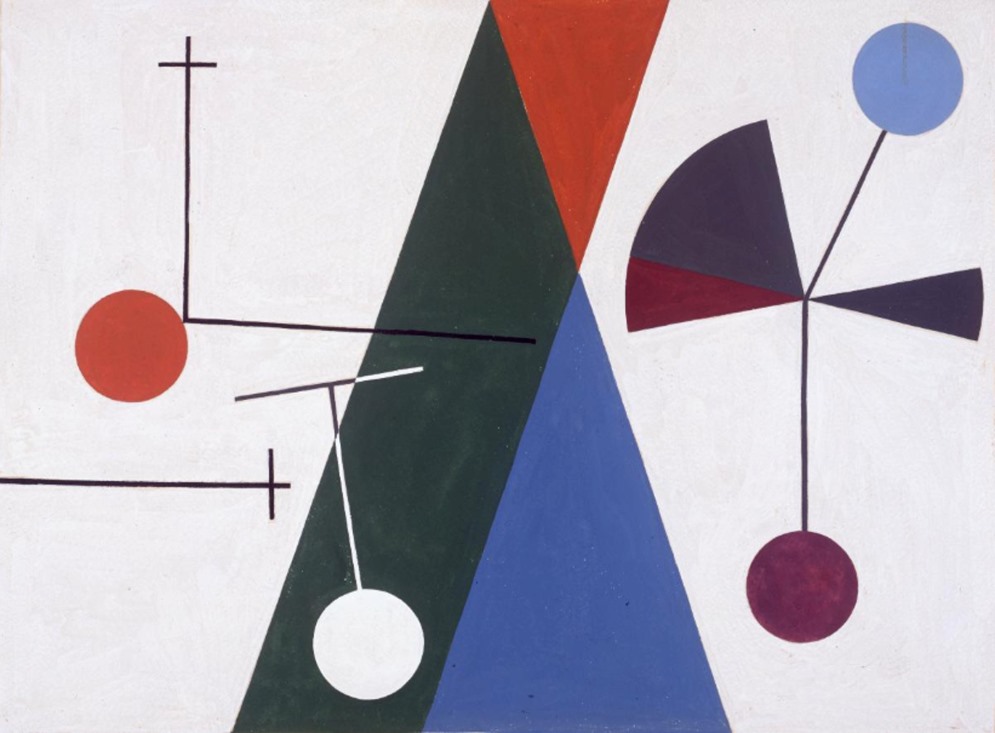Poesia: tradotta in tedesco da Christoph Ferber la raccolta postuma di Giorgio Orelli
A dodici anni dalla scomparsa del suo autore esce oggi per la prima volta in edizione autonoma l’ultima, per quanto incompiuta, raccolta poetica di Giorgio Orelli. La notizia è di quelle che meritano di essere festeggiate: nei cataloghi delle biblioteche, oltre che in quello della casa editrice Limmat di Zurigo, d’ora innanzi esisterà infatti come titolo indipendente L’orlo della vita, la citazione dantesca che Orelli aveva scelto per raccogliere i versi dei suoi anni più estremi, scritti dall’orlo di un’esistenza già proiettata verso un «di là» intriso di mistero e malinconia, e contemporaneamente così pieni di lontane memorie giovanili, tra Airolo, Prato, Faido e l’Ascona del Collegio Papio.
Alcuni di questi testi, conservati dattiloscritti in una cartelletta mostrata a pochi intimi, erano stati anticipati prima del 2013 in edizioni d’arte, volumi miscellanei o fascicoli di riviste (su «Viceversa», «Poesia», «Cenobio»), ma ancora mancava il disegno complessivo della raccolta, a cui l’autore continuò a lavorare fino alla fine dei suoi giorni senza purtroppo poter concludere l’opera.
In occasione dell’uscita dell’Oscar Mondadori con Tutte le poesie, nel 2015 Pietro De Marchi si era sobbarcato l’ardua fatica di studiare e pubblicare quelle carte con criteri filologici rigorosi e prudenti, nel pieno rispetto – per quanto possibile – della volontà dell’autore. Nonostante il fatto che i testi fossero quindi disponibili sin da allora ai lettori italiani, anche se un po’ nascosti tra le pagine finali dell’Oscar, fa ben altro effetto ritrovarseli oggi tra le mani in questa nuova veste, selezionati, curati e tradotti con competenza da un professionista della caratura di Christoph Ferber. Con questa pubblicazione si può ben dire insomma che l’Orlo inizi finalmente una sua propria vita editoriale.
L’impresa non deve essere stata delle più semplici, se è vero che oltre alle difficoltà insite nella lingua poetica di Orelli (fitta di rimandi cólti alla più grande tradizione italiana: da Dante a Leopardi passando per Ariosto) nel libro compaiono alcuni testi composti in dialetto leventinese che Ferber, nativo di Sachseln, ha pensato intelligentemente di tradurre nella sua stessa parlata materna, l’Obwaldnertütsch. Fa sorridere il pensiero che a volte, persino per un buon conoscitore del «dialetto della ferrovia» quale mi ritengo, sia quasi più comprensibile la nuova versione che non l’originale orelliano: «I ’l so be’ / cus ti péisat, ti péisat cu i varés / un grèi di chela murtadela» (reso dal traduttore con «Ich wäiss es, / was tänksch, dui tänksch, äs gheerti da / no ä chli Mortadella drzuä»). Non parliamo poi del memorabile attacco di Clandestina: «Da lusc u m pereva ’l taplöc / di cèuri da Cüroni, / ma l’éra ’na fömnèta, trècia sü / ’me na zingra», con la sua significativa sovrapposizione di mondi, quello dei campanacci delle capre di Chironico e quello dei suonatori ambulanti di origine andina.
Nel complesso, l’ultimo Orelli pare davvero una summa di tutta la sua esperienza letteraria passata, con in aggiunta un tasso di dolcezza e di garbo che non mancherà di commuovere i lettori. Non si contano infatti i «non», i «poco», i «forse», i «senza», i «mai», in un infittirsi di affermazioni negate, di atmosfere attutite dalla lingua («né vecchio né giovane», «né gravi né convinti», «né scoppia né crepa») prima ancora che dalla lontananza dei ricordi: «Da Milano a Pavia / ci sono treni che hanno così poca / fretta che, a volte, in primavera, quando / spuntano i primi cespi smerlettati, / prendono la campagna lenti lenti […] guardati da santi / che in cima a campanili alzano un piede / come per volare via».
Dall’esile ma ricco ventaglio dell’Orlo della vita, specie per chi abbia un po’ di dimestichezza con le raccolte precedenti, si irraggiano a ritroso innumerevoli fili che recuperano le ben note scene del poeta alle prese con le prime scoperte entusiaste di figlie o nipoti, così come le mai smussate punte di poesia civile (i cosiddetti «cardi») o i sempre sorprendenti incontri con persone già in là con gli anni, pronte a condividere con chi scrive il nucleo fondante della loro saggezza, secondo un fortunato modello inaugurato con Sinopie (1977): «Irrompe strepitando oltre misura / nel breve sottopasso / dove talvolta si fermano vecchi / a prender fiato». O ancora: «Aspetto che si dia / tempo al tempo e anch’essa maturi / e lenta allungandosi, tremula / lacrima senza brillìo, / dal naso del vecchio la goccia / si stacchi». Giunto oramai nel loro gruppo, Orelli può mettere in scena ironicamente se stesso come un anziano e lento «uomo da marciapiede» superato a destra e a manca da ragazzine in skateboard e da bambini che le biciclette le usano per davvero, simpatiche metafore di un mondo che non si ferma a chiedere il permesso e continua allegro per la sua strada.
Credo che questa peculiare atmosfera di sospensione e attenuazione, arricchita da incontri quotidiani e ritracciabile in misura diversa in tutto il libro, si debba anche alla sempre presente memoria dantesca e, entro quella, alla cantica che più di tutte deve avere nutrito negli ultimi anni l’Orelli lettore: il Purgatorio. Da quella derivano infatti non soltanto il titolo della raccolta («quello spirito ch’attende, / pria che si penta, l’orlo de la vita», Purg. XI), ma anche l’immagine della vita «viziata e lorda» (Purg. VI, citato in Libia) a causa della quale risulta quasi inevitabile una pur timida richiesta di perdono. Si tratta, in fondo, del motivo stesso dell’invenzione medievale della montagna del Purgatorio, un sistema che impone alle anime un ripensamento della loro intera esistenza, con uno sguardo contemporaneamente molto umano e molto divino, compassionevole e severo al tempo stesso. La «dolce stagione» della giovinezza a cui Orelli ha dedicato molte delle poesie dell’Orlo, pescando in Dante l’emistichio che completa il verso da cui già proveniva il suo celebre L’ora del tempo (1962), si iscrive proprio in questa dinamica tipica dell’età matura.
A livello strettamente formale, assieme ai consueti giochi fonosimbolici cui ci ha abituato da sempre il poeta di Bellinzona, qui a tratti persino funambolici («inghirlandata di glicine e gracili / roselline»; «uno scompiglio d’ombre / scagliate da una sùbita famiglia / di corvi, ed esultante / disse: “Ci giacigliamo nelle foglie”»), ritornano in quest’ultimo libro quelle che Pietro De Marchi ha giustamente individuato quali vie maestre dello stile poetico orelliano: da una lato il distendersi piano e quasi prosaico della narrazione, dall’altra il cristallo limpido della poesia pura. Alla prima categoria appartengono quasi tutti i testi dedicati alle memorie giovanili, alla riscoperta della casa paterna e ai ricordi di scuola – negli anni Trenta – presso i padri benedettini di Ascona. Alla seconda un capolavoro di equilibrio e di metrica come questo: «Sembra eccessivo l’odore / di gelsomino in cui vo ringioito / da questa farfalla / bianchissima che vòlita / vantandosi di nulla / e in cima alla salita controvento / sbietta verso un giardino, / si posa su un corimbo / di melo, si fa fiore».
Fatta salva la qualità sempre molto alta dei volumi stampati da Limmat Verlag, sorprende in negativo purtroppo il prezzo di copertina: 38 CHF per un volumetto di un centinaio di pagine e di una quarantina di testi, raddoppiati dalla traduzione. Ma sono forse polemiche sterili: la verità è che il libro di Orelli e la traduzione di Ferber – che Oltralpe e in Germania stanno già avendo tutto il successo che meritano, persino su «Die Zeit» – ne valgono almeno il doppio.