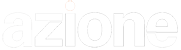Camminando ai primi di marzo lungo la Münstergasse, all’incrocio con la Schoffelgasse, incontro come ho già incontrato chissà quante volte senza però studiarla con la dovuta cura, l’insegna-scudo della Bodega española di Zurigo (417 m). Su campo rosso granato come certi rioja crianza, si leggono le quattordici lettere giallo oro – più la tilde – che compongono il nome di questo luogo nato nel 1874. Senza tirare in ballo più di tanto il richiamo ovvio alla bandiera spagnola, salgo con gli occhi in cima, tra i tralci di vite in ferro battuto. Lì, guardando con attenzione estrema, troneggia, incorniciato da un sipario, il monastero benedettino miniaturizzato di Sant Pere de Rodes. In Catalogna, nella comarca di Alt Empordà, sulle prime pendici brulle dei Pirenei, questo austero monastero preromanico in pietra si erge turrito guardando il Mediterraneo. Ai suoi piedi, a circa due chilometri, si trova l’unico villaggio isolato della zona, La Vall de Santa Creu: da dove è partito Pedro Gorgot (1845-1933). Il fondatore della Bodega zurighese dove adesso un vecchietto in trench blu è seduto fuori perché non vuole rinunciare alla combinazione bianchino-brissago.
Con il movimento del cavallo negli scacchi, entro nella prima sala della Bodega Gorgot come era anche nota ad alcuni e così appare, presto, tra le pagine del Tagebuch 1966-1971 (1972) di Max Frisch. Ritorna poi una quindicina di volte chiamata solo «bodega» e sempre in compagnia di un orafo tribolato che beve troppo clarete. C’ero stato solo una volta, secoli fa, un pomeriggio alla deriva. Seduto a uno dei cinque tavoloni in legno chiaro liscio e lucido come uno specchio, subito mi rendo conto che l’atmosfera e l’ambiente sono preservati. Temevo, visto che quest’estate c’è stato un cambio di proprietà e a snaturare oggi è un attimo, invece le sedie Thonet tipo bistrò in faggio curvato-laccato e paglia di Vienna intrecciata, sono ancora lì al loro posto. A un lato dei tavoli, per sedersi, ci sono anche delle nicchie-divanetti in pelle vissuta color vinaccia. In tinta un po’ con la boiserie spennellata di una tonalità bruna-bordò. Ma è il pavimento che dimostra come un restauro può essere sul serio conservativo senza perdere centocinquant’anni di storia intrisa di drammi, gioie, paure, liberazioni, risate, riti, uscite rapide di scena o andirivieni estenuanti: rimane ben visibile il solco circolare tra le sedie attorno allo stammtisch qui accanto, per esempio. Attorno al quale siedono, da ore credo, tre con le facce da architetti. Osservando ancora per terra, si nota il tragitto-solco del viavai ultrasecolare dei camerieri, oggi in camicia bianca e gilet nero.
Il monastero mediterraneo risalente al 945 ritorna, al pianterreno di questa casa del 1524 verso le tre, sul menu, come logo. Al mio tavolo uno della mia età circa affoga le sue preoccupazioni in bicchieri di vino rosso cupo. Un signore entra in scena salutando come Churchill, prende il giornale e si siede a un tavolo che a pelle sento che sarà, ogni giorno, sempre quello. È il tavolo di Lenin che nel 1916 abita per un anno qui dietro l’angolo, al quattordici della Spiegelgasse dove al contempo, per cinque mesi, nella stessa strada al numero uno, in una sala sotto di una taverna olandese, c’era il Cabaret Voltaire. Qui sopra, dal 1894, c’è la sala morisca, più ristorante e meno conviviale. Di casa, dicono, c’è l’ex batterista dei Sauterelles. Degne di nota, le finestre acidate con ricami come tendine di pizzo che contribuiscono all’atemporalità, mentre i portamantelli d’ottone portano in altre epoche.
Al di là del mobilio oppiaceo, l’atmosfera è genuina, spigliata, come solo dove ne hanno viste di tutti i colori. Vado a vedere le tapas – introdotte nell’era della famiglia Winistörfer durata settantuno anni senza cambiare una virgola dal periodo Gorgot II e anzi, inspagnolendo di più la bodega – come calamari, alici, eccetera, in bellavista dietro una bacheca. Alla fine però, la cosa migliore, per me, è il flan. Una flânerie di precisione, addirittura, potrebbe magari riportarmi qui per questa ragione. Ma già l’hola che sostuisce il grüezi e il continuo parlare spagnolo dei camerieri spagnoli che contagia un po’ tutti come una recita dove proviamo tutti a parlare pure, bene o male, in spagnolo, varrebbe la pena come meta di una passeggiata psicogeografica turicense seria.